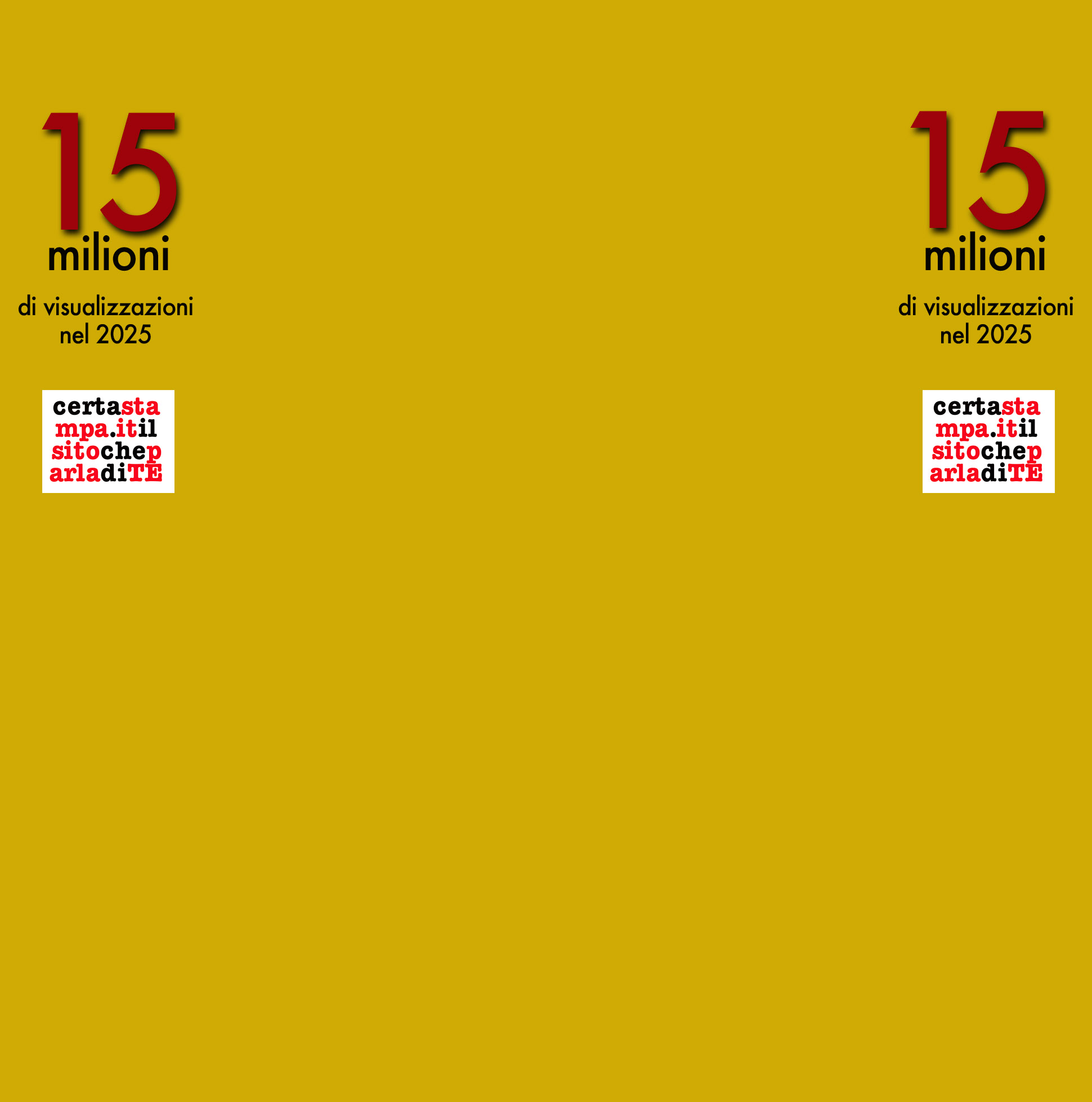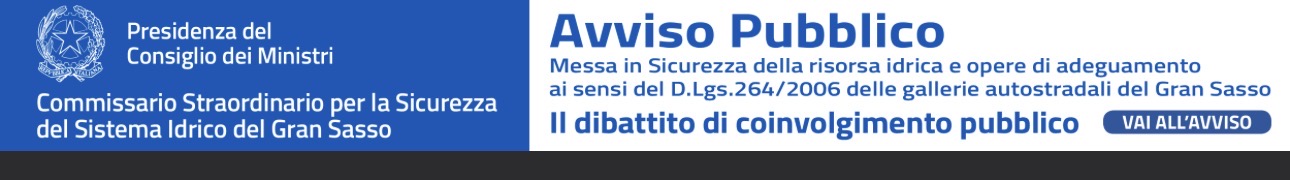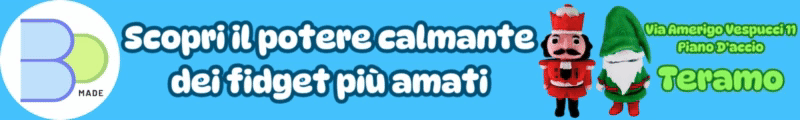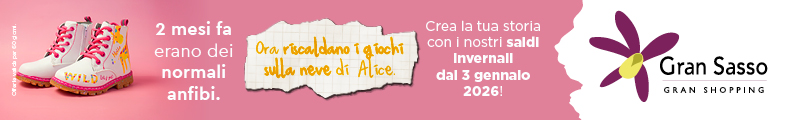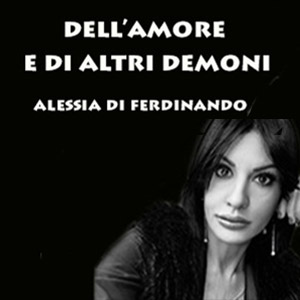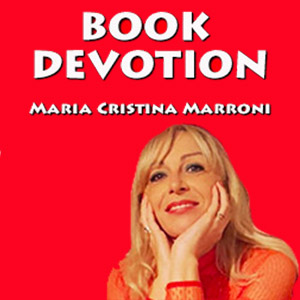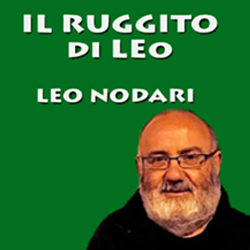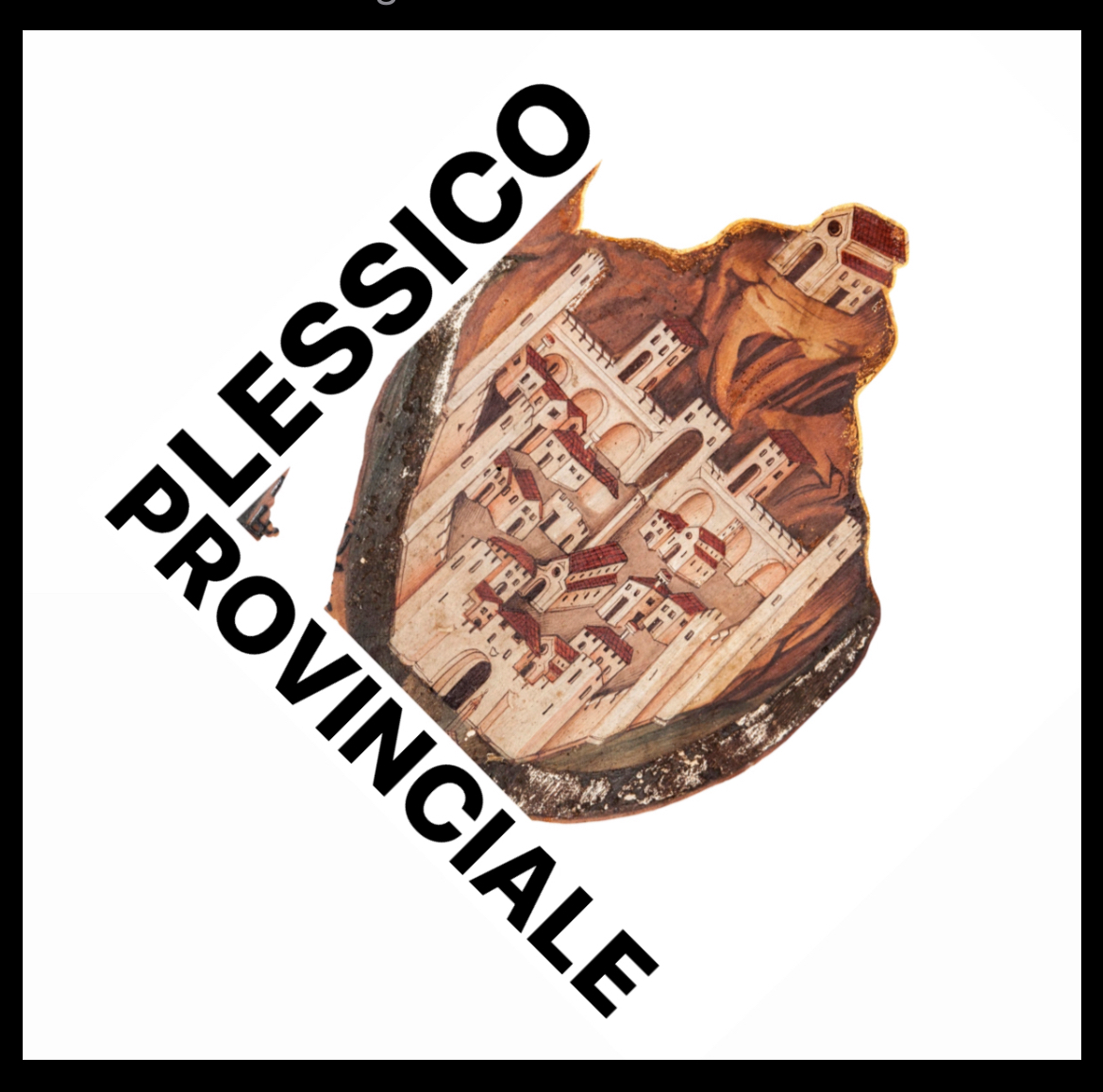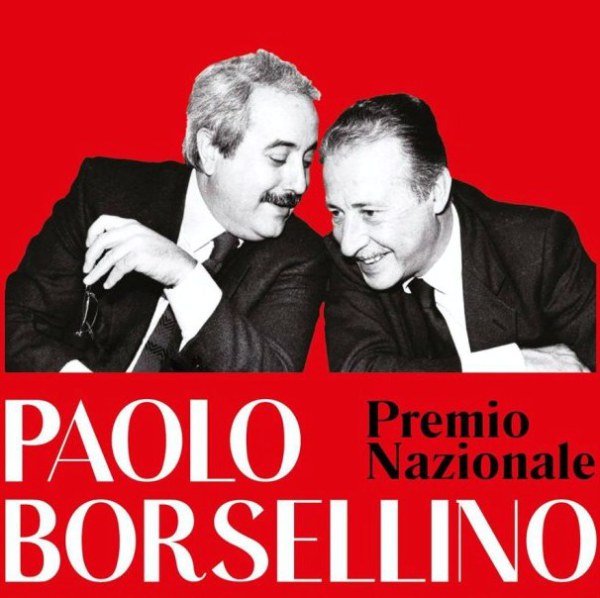Nella sua “Introduzione storico artistica agli studi del piano regolatore della città di Teramo” (Teramo, Casa Editrice Tipografica Teramana, 1934-XII) Luigi Savorini scriveva che analizzando la storia del progresso edilizio e dell’urbanistica teramana si era costretti a ricavarne un concetto bon troppo elevato. Si doveva riconoscere che gli sforzi fatti non avevano portato a grandi risultati. Mancando a Teramo una tradizione edilizia, e non potendosi esemplare i nuovi edifici sui modelli troppo modesti di quelli medioevali, era venuto a mancare alle costruzioni moderne un tipo che potesse armonizzarle. La mancanza di buona pietra da costruzione aveva destituito di ogni monumentalità la nuova edilizia. I criteri di economia nel restauro o nel rifacimento degli edifici pri vati (molte case, anche sul Corso, avevano i piani di altezza sproporzionata a quello terraneo, perché si era voluto conservare gli antichi bassi), gravi errori di ubicazione e di impostazione di edifici nuovi anche importanti, avevano fatto apparire meno evidente il risultato degli sforzi compiuti. Non si aveva avuto mai il coraggio in tanti anni di effettuare una espropriazione per utilità pubblica. Per questo motivo ed anche per ostacoli e difficoltà contingenti che bisognava saper superare, quasi tutti i nuovi edifici erano stati ubicati in strade secondarie, se non addirittura in zone sconvolte, con complicazione, anzi che con semplificazione, dei problemi di viabilità e di edilizia. Il Corso di Teramo era rimasto presso a poco quel che era trent'anni prima ed al forestiero che dal Corso non si fosse troppo allontanato non sarebbe apparso quanto di bello e di nuovo si era aggiunto. Si doveva inoltre considerare che, se la città era facilmente percorribile e visibile da un capo all'altro dei due corsi, non lo era altrettanto trasversalmente e, invece di abolire gli sbarramenti, se ne era prodotto qualche altro. Per la mancanza di rettifili trasversali, in nessun punto era consentito abbracciare con lo sguardo la città in tutta la sua larghezza, cosi che essa appariva immiserita in una angustia che le poteva essere risparmiata. Tuttavia, non ostante questi difetti, Teramo si presentava gaia, luminosa, ariosa e ridente e al visitatore faceva migliore impressione di altre città dove nelle troppo severe facciate degli antichi palazzi il travertino piangeva le sue eterne lacrime.
Nella sua “Introduzione storico artistica agli studi del piano regolatore della città di Teramo” (Teramo, Casa Editrice Tipografica Teramana, 1934-XII) Luigi Savorini scriveva che analizzando la storia del progresso edilizio e dell’urbanistica teramana si era costretti a ricavarne un concetto bon troppo elevato. Si doveva riconoscere che gli sforzi fatti non avevano portato a grandi risultati. Mancando a Teramo una tradizione edilizia, e non potendosi esemplare i nuovi edifici sui modelli troppo modesti di quelli medioevali, era venuto a mancare alle costruzioni moderne un tipo che potesse armonizzarle. La mancanza di buona pietra da costruzione aveva destituito di ogni monumentalità la nuova edilizia. I criteri di economia nel restauro o nel rifacimento degli edifici pri vati (molte case, anche sul Corso, avevano i piani di altezza sproporzionata a quello terraneo, perché si era voluto conservare gli antichi bassi), gravi errori di ubicazione e di impostazione di edifici nuovi anche importanti, avevano fatto apparire meno evidente il risultato degli sforzi compiuti. Non si aveva avuto mai il coraggio in tanti anni di effettuare una espropriazione per utilità pubblica. Per questo motivo ed anche per ostacoli e difficoltà contingenti che bisognava saper superare, quasi tutti i nuovi edifici erano stati ubicati in strade secondarie, se non addirittura in zone sconvolte, con complicazione, anzi che con semplificazione, dei problemi di viabilità e di edilizia. Il Corso di Teramo era rimasto presso a poco quel che era trent'anni prima ed al forestiero che dal Corso non si fosse troppo allontanato non sarebbe apparso quanto di bello e di nuovo si era aggiunto. Si doveva inoltre considerare che, se la città era facilmente percorribile e visibile da un capo all'altro dei due corsi, non lo era altrettanto trasversalmente e, invece di abolire gli sbarramenti, se ne era prodotto qualche altro. Per la mancanza di rettifili trasversali, in nessun punto era consentito abbracciare con lo sguardo la città in tutta la sua larghezza, cosi che essa appariva immiserita in una angustia che le poteva essere risparmiata. Tuttavia, non ostante questi difetti, Teramo si presentava gaia, luminosa, ariosa e ridente e al visitatore faceva migliore impressione di altre città dove nelle troppo severe facciate degli antichi palazzi il travertino piangeva le sue eterne lacrime.
Passando a parlare delle case di abitazione per i1 popolo, Savorini ricordava che ventitrè anni prima, quando nel 1910 si era sotto le minacce di una infezione colerica, era stato costituito anche a Teramo un “Comitato di vigilanza per la salute pubblica”, il quale, compiuta una rigorosa inchiesta, aveva posto nel dovuto rilievo le condizioni abitative delle classi meno abbienti della popolazione. La dettagliata relazione, purtroppo rimasta sepolta negli archivi, riportava brani descrittivi assai interessanti sotto il punto di vista edilizio. Per esempio si leggeva: “La povera gente abita nei fondaci, ossia nei bassi, che sono locali umidi, al di sotto qualche volta del livello stradale, a mala pena utilizzabili per legnaie o per cantine, e dove pur tuttavia si ricoverano famiglie composte ben più che di due persone. Questi miserandi abituri, senza luce, senz'aria, senza camini, senza impianto d'acqua potabile, senza acquai e senza convoglio degli umani rifiuti, senz'altra apertura che la porta d'ingresso, sono abitati, in mancanza di meglio, anche da buoni operai, che fanno talvolta miracoli d'industria per tener bene pulita e assestata la loro stamberga, dove una parete fa da cucina, un'altra da camera da letto, una terza da laboratorio. In queste cieche caverne uno stesso letto accoglie talvolta tutti i componenti la famiglia. E dormono nella stessa stanza dove il giorno si lavora, si cucina, si sta a desinare.Durante la stagione estiva quella gente si riversa per quasi tutta la giornata sulla strada, che diventa così un'appendice delle loro abitazioni. Sulla strada qualche uomo porta gli apparecchi e i ferri del mestiere, le donne lavorano o s'accapigliano con grandi schiamazzi, i bambini ruzzano, voltolandosi sul selciato. Sono esposti così a tutte le infezioni a tutti i contagi e sono minati tanto nel fisico che nel morale.”
Secondo Savorini, occorreva un'opera di risanamento, che costituiva una delle più impellenti urgenze edilizie. Dal 1910 qualche cosa era stato fatto al riguardo. La “Fratellanza Artigiana” nel 1923 aveva costruito un nuovo caseggiato operaio al Piano del Vescovo. Le migliorate condizioni economiche delle classi lavoratrici e le provvidenze del Regime fascista avevano elevato il tono di vita di alcune famiglie di operai e consentito loro migliori abitazioni. La sollecitudine dell' Amministrazione Comunale aveva concesso a varie famiglie povere di abitare a prezzi modestissimi, se non a dirittura gratuitamente, in alcuni locali dell'ex Convento di S. Giovanni e nel quartiere dell'Orto Agrario. Ma la gran massa della povera gente viveva ancora nelle stesse condizioni del 1910, ed anche se ne avesse avuto i mezzi finanziari, non avrebbe trovato dove meglio allogarsi per la crisi permanente degli alloggi. Savorini riteneva che questo dovesse essere uno degli obiettivi del piano regolatore che si doveva varare ed approvare, per ragioni di umanità e di pubblico decoro. Se l’obiettivo principale del Piano Regolatore era quello di prospettare le aspirazioni estetiche e la bellezza avvenire di Teramo, quale bellezza sarebbe stata “più degna, più pura di una città liberata dalle abitazioni malsane e dai viluppi delle zone più antiquate e antigieniche e restituita interamente al sorriso del sole, agli aliti della sanità?”Occorreva però, secondo Savorini, non relegare la classe operaia in quartieri fuori all'abitato, si sarebbero costruiti dei ghetti. Gli operai teramani erano artigiani, più che braccianti o lavoratori d'officine, occorreva tenere loro e le loro botteghe al centro della città,, così come le loro abitazioni. In una città in cui anche pel corso c’erano ancora molte case ad un solo piano, sarebbe bastato sopraelevarne poco più di un centinaio per risolvere la questione degli alloggi. I giardini e gli orti annessi ad un così gran numero delle case signorili non bisognava tenerli chiusi con muri di cinta, alla pare di conventi o di cimiteri. Si doveva consentire che, sia pure attraverso i cancelli, anche il popolo avesse in ogni strada la sua visione di verde, l'estetica di una città non era fatta soltanto di grazie monumentali, ma di civiltà, di sanità, di bellezza morale. I teramani di oggi sanno che tutto ciò che al riguardo Savorini auspicava non si è realizzato, anzi si è proceduto nella direzione del tutto opposta: il centro storico di Teramo si è progressivamente svuotato non solo della funzione abitativa (non solo sono stati espulsi gli artigiani e le loro botteghe, ma anche i ceti medi, sono stati costruiti ghetti e dormitori in squallide periferie, la centralità abitativa è scivolata verso Collatterrato e San Nicolò), ma anche di altre funzioni non abitative, diventando di fatto un guscio vuoto, dal quale ultimamente sono state espulse anche scuole prestigiose quali la “Savini” e il “Delfico”.
Elso Simone Serpentini