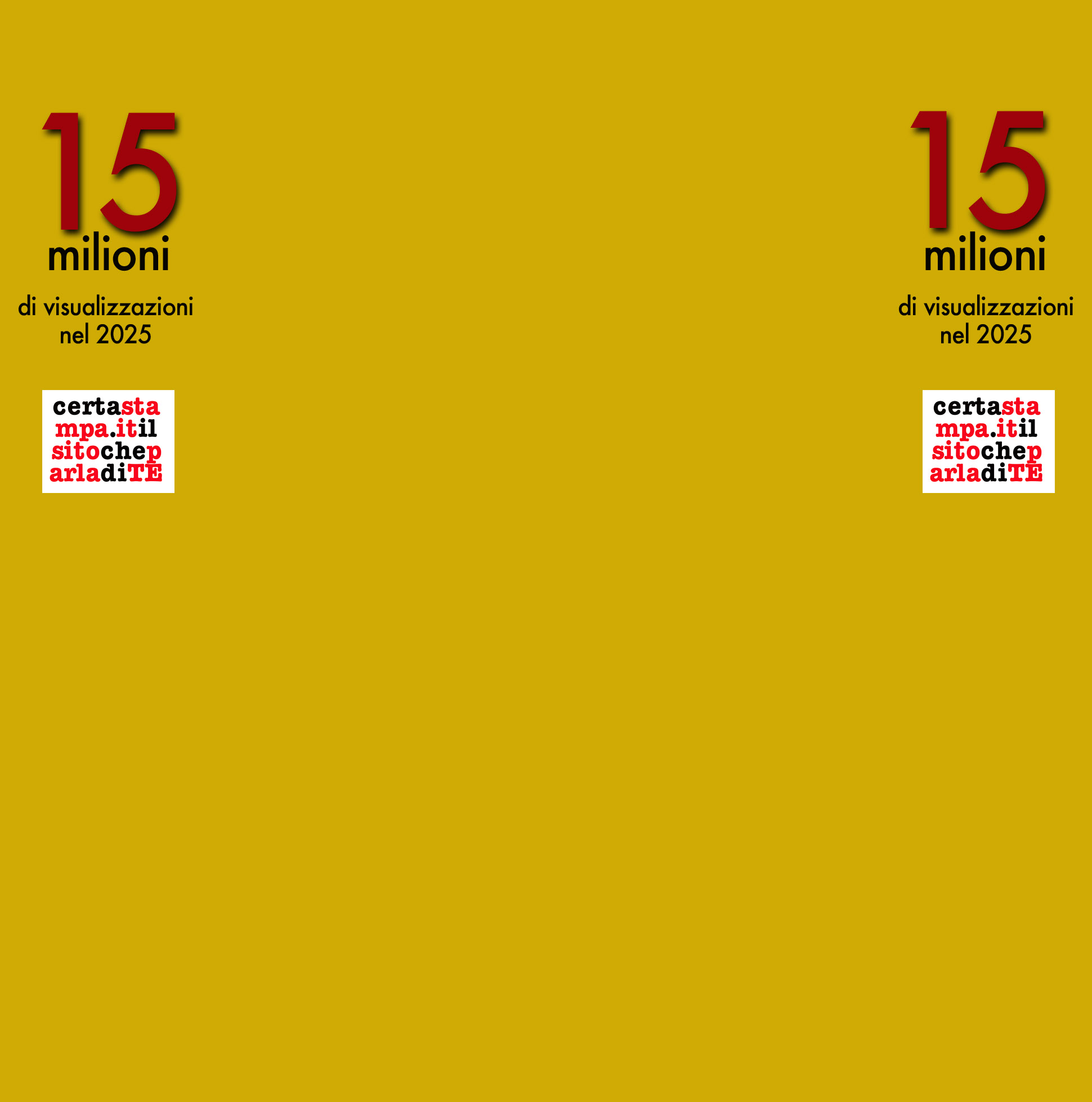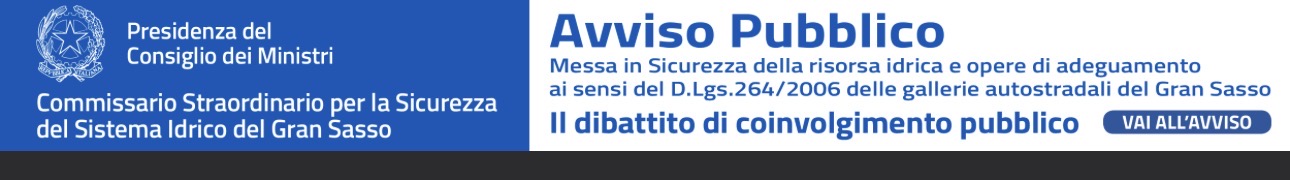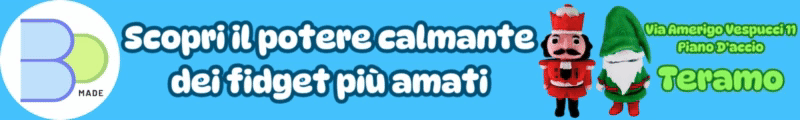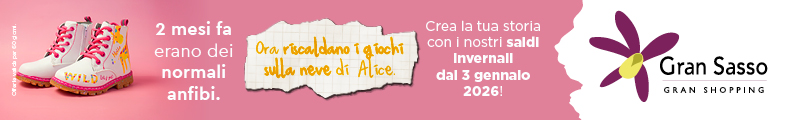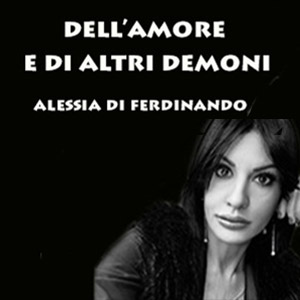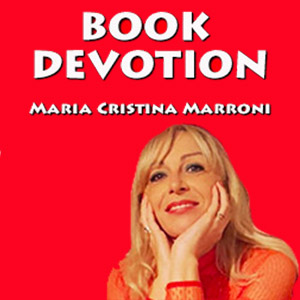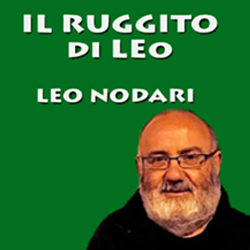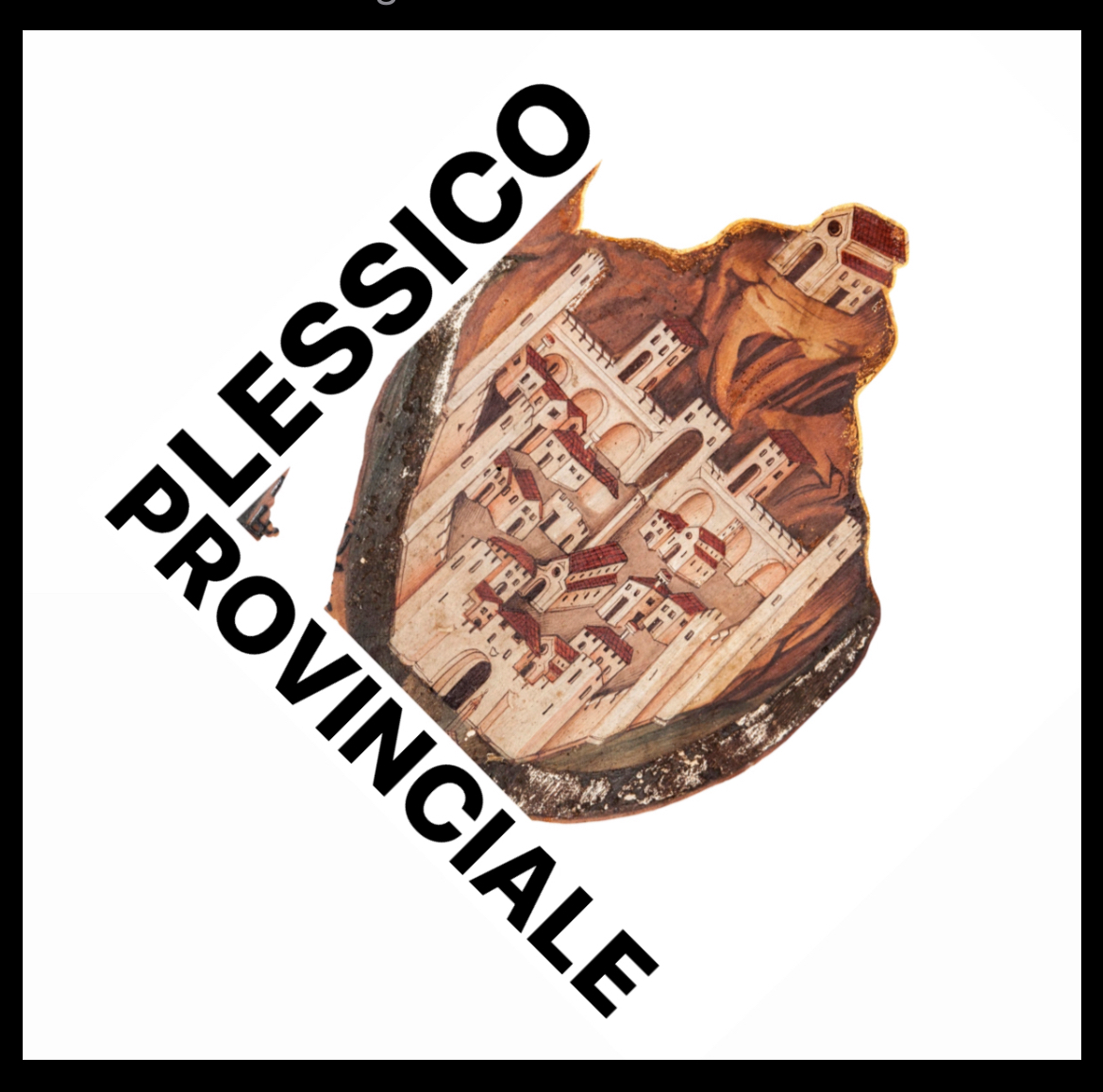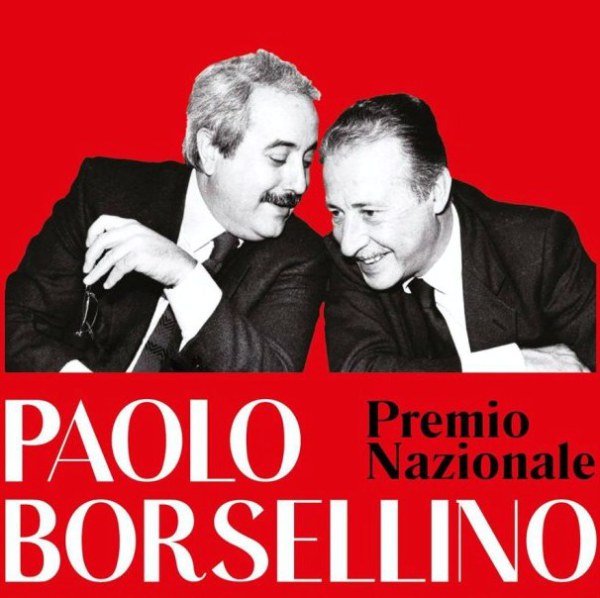Nella sua “Introduzione storico artistica agli studi del piano regolatore della città di Teramo” (Teramo, Casa Editrice Tipografica Teramana, 1934-XII) Luigi Savorini, parlando del progetto di isolamento del Duomo che sembrava finalmente avviato, poneva un quesito che definiva “inquietante”: che fare del così detto Arco di Monsignore, ossia del cavalcavia tra la Cattedrale e l’Episcopio? Abbatterlo o conservarlo? Avrebbe resistito anche questa volta ai propositi di demolizione? Dopo la scomparsa di tutte le porte, di tutte le mura e di quasi tutte le torri medioevali, sarebbe scomparso anche questo cavalcavia, l'unico superstite, dopo l'abbattimento cui assistemmo dell'arco dei Grue? Savorini si chiedeva se un cavalcavia non fosse anch'esso un elemento di grazia, una interruzione di monotonia nell'aspetto di una città. Non è una grande opera d'arte, ammetteva, quell'arco a tutto sesto che sosteneva la Cappella Vescovile e il passaggio segreto tra l'episcopio e la cattedrale. Non aveva neppure il pregio della vetustà, perchéaveva meno di duecento anni di vita, sorto nel 1738 sotto il vescovo De Rossi. Ma tra le due piazze s'aprivacome uno scenario, attraverso il quale si facevano l’occhiolino la città vecchia e la città nuova. Se in quell’arco non c’era arte, c'eraqualche cosa di equivalente: il pittoresco. Però da che i mezzi di locomozione erano divenuti così ingombranti e veloci, sotto quell'arco il transito era reso difficile e pericoloso. Savorini scriveva: “Non abbiamo cuore di condannarlo, ma non sapremmo neppure che suggerire per salvarlo, a meno che non si volesse rinunciare a veder le basi del campanile anche dalla Piazza del Mercato ed aprire nel corpo di fabbrica tra l'Arco di Monsignore e la Cattedrale due archi minori, pari a quelli del porticato vescovile. Potrebbero servire questi due archi minori, se distaccati dal campanile, di passaggio per i pedoni. Lasciamo ai progettisti e agli amministratori della cosa pubblica il compito di risolver la questione”. Ai tecnici, tuttavia, Savorini si credeva obbligato di ricordare che l'Arco di Monsignore costituiva essere un grande sostegno pel campanile, che spiombava di 12 centimetri e che, come risultavadai verbali della Commissione Conservatrice (3 luglio 1909), a detta dell’arch. Viviani, avrebbe potuto pericolare qualora il detto arco fosse tolto. Egli si credeva pure obbligato a far presente che un rettilineo tra il Corso S. Giorgio e la Piazza del Mercato non sarebbe mai stato possibile ottenerlo, perché non in asse, e che il campanile a sua volta non era in linea né col fianco superiore nécon quello inferiore del Duomo, perché innalzato su basi non accordate, chi sa per quale ragione, con i due corpi della cattedrale. In caso di abbattimento dell'arco, queste dissimetrie sarebbero apparse evidenti e sarebbe stato necessario ovviarvi con zone di verde o altri espedienti.Savorini scriveva di aver rilevatosolo per debito di coscienza le segnalate difficoltà, che forse ad un più attento esame ed all'atto pratico sarebbero apparse meno preoccupanti. E unicamente per amore d’obbiettività avevaprospettato le due soluzioni che si presentavano nella questione dell'Arco, sapendo molti erano impazienti di vederlo abbattuto, ma erano altrettanto numerosi quanti desideravano vederloconservato. L'importante, concludeva, era porre mano ai lavori, i primi scoprimenti avrebbero suggerito le direttive da seguire. L'importante era che il Foro della nuova Interamnia incominciassea delinearsi non più nei tracciati ipotetici di un grafico schematico, ma nelle linee e nelle risultanze reali, sempre più convincenti d'ogni più meditata previsione.
Nella sua “Introduzione storico artistica agli studi del piano regolatore della città di Teramo” (Teramo, Casa Editrice Tipografica Teramana, 1934-XII) Luigi Savorini, parlando del progetto di isolamento del Duomo che sembrava finalmente avviato, poneva un quesito che definiva “inquietante”: che fare del così detto Arco di Monsignore, ossia del cavalcavia tra la Cattedrale e l’Episcopio? Abbatterlo o conservarlo? Avrebbe resistito anche questa volta ai propositi di demolizione? Dopo la scomparsa di tutte le porte, di tutte le mura e di quasi tutte le torri medioevali, sarebbe scomparso anche questo cavalcavia, l'unico superstite, dopo l'abbattimento cui assistemmo dell'arco dei Grue? Savorini si chiedeva se un cavalcavia non fosse anch'esso un elemento di grazia, una interruzione di monotonia nell'aspetto di una città. Non è una grande opera d'arte, ammetteva, quell'arco a tutto sesto che sosteneva la Cappella Vescovile e il passaggio segreto tra l'episcopio e la cattedrale. Non aveva neppure il pregio della vetustà, perchéaveva meno di duecento anni di vita, sorto nel 1738 sotto il vescovo De Rossi. Ma tra le due piazze s'aprivacome uno scenario, attraverso il quale si facevano l’occhiolino la città vecchia e la città nuova. Se in quell’arco non c’era arte, c'eraqualche cosa di equivalente: il pittoresco. Però da che i mezzi di locomozione erano divenuti così ingombranti e veloci, sotto quell'arco il transito era reso difficile e pericoloso. Savorini scriveva: “Non abbiamo cuore di condannarlo, ma non sapremmo neppure che suggerire per salvarlo, a meno che non si volesse rinunciare a veder le basi del campanile anche dalla Piazza del Mercato ed aprire nel corpo di fabbrica tra l'Arco di Monsignore e la Cattedrale due archi minori, pari a quelli del porticato vescovile. Potrebbero servire questi due archi minori, se distaccati dal campanile, di passaggio per i pedoni. Lasciamo ai progettisti e agli amministratori della cosa pubblica il compito di risolver la questione”. Ai tecnici, tuttavia, Savorini si credeva obbligato di ricordare che l'Arco di Monsignore costituiva essere un grande sostegno pel campanile, che spiombava di 12 centimetri e che, come risultavadai verbali della Commissione Conservatrice (3 luglio 1909), a detta dell’arch. Viviani, avrebbe potuto pericolare qualora il detto arco fosse tolto. Egli si credeva pure obbligato a far presente che un rettilineo tra il Corso S. Giorgio e la Piazza del Mercato non sarebbe mai stato possibile ottenerlo, perché non in asse, e che il campanile a sua volta non era in linea né col fianco superiore nécon quello inferiore del Duomo, perché innalzato su basi non accordate, chi sa per quale ragione, con i due corpi della cattedrale. In caso di abbattimento dell'arco, queste dissimetrie sarebbero apparse evidenti e sarebbe stato necessario ovviarvi con zone di verde o altri espedienti.Savorini scriveva di aver rilevatosolo per debito di coscienza le segnalate difficoltà, che forse ad un più attento esame ed all'atto pratico sarebbero apparse meno preoccupanti. E unicamente per amore d’obbiettività avevaprospettato le due soluzioni che si presentavano nella questione dell'Arco, sapendo molti erano impazienti di vederlo abbattuto, ma erano altrettanto numerosi quanti desideravano vederloconservato. L'importante, concludeva, era porre mano ai lavori, i primi scoprimenti avrebbero suggerito le direttive da seguire. L'importante era che il Foro della nuova Interamnia incominciassea delinearsi non più nei tracciati ipotetici di un grafico schematico, ma nelle linee e nelle risultanze reali, sempre più convincenti d'ogni più meditata previsione.
I teramani di oggi sanno che l’Arco di Monsignore sopravvisse ai lavori di isolamento del Duomo, e venne abbattuto solo anni più tardi, nel secondo dopoguerra, con decisione tardiva e contestata. C’è oggi chi lo rimpiange vedendone il campanile del Duomo spoglio e messo a nudo. C’è chi ritiene che sia stato un errore. Non sappiamo cosa penserebbe oggi Savorini nel vederlo effettivamente abbattuto né sappiamo se il suo abbattimento lo confiderebbe congruo con quanto egli si aspettava come conseguenza del programma della sistemazione del centro cittadino che nel 1934 ci si apprestava ad attuare. Era un programma che gli piaceva, tanto da indurlo a dettare un auspicio, scrivere, a conclusione del suo scritto, che quanto ci si apprestava a fare non fosse disturbate o compromesse dal capriccio degli architetti e degli amministratori futuri. Era un programma le cui sembravano uscite dal fervore di una fantasia, ma non avrebbero tardato a determinarsi nella realtà. Concludeva “Riconosciamo che in quanto abbiamo ideato è della passione per questa città che abbiamo tanto amata. Ma non c'è soltanto della speranza, c'è anche della convinzione. Nel mettere insieme questa esposizione, che principia dall'epoca preromana e guarda infine all'avvenire, ci è sembrato talvolta di narrar le vicende d'un lungo martirio subito attraverso i secoli dalla città nostra, da quando, perduta la grande pace romana, non ebbe più bene e riposo. Quante distruzioni, e dovute unicamente alla mano degli uomini, in una città cui la natura non produsse mai alcun danno! Ma oggi la pace romana è risorta. La fattività costruttiva del popolo romano rinasce in tutta la Nazione. Anche oggi si abbatte, ma per ricostruire. Ed ogni pietra che si aggiunge rimarrà intangibile per l’avvenire. Nell'atmosfera odierna di opere rinnovatrici, i Teramani seguono con vigoria maschia la volontà tenace che viene da Roma. Agli scettici, a coloro che sorridono dell'aspirazione di una piccola città a seguir gli esempi dell’Urbe, rispondiamo che allora l’Italia apparirà veramente grande e bella, quando anche ogni piccolo capoluogo di provincia sarà sano, sarà bello, sarà maestoso, come un quartiere di Roma.”
Elso Simone Serpentini