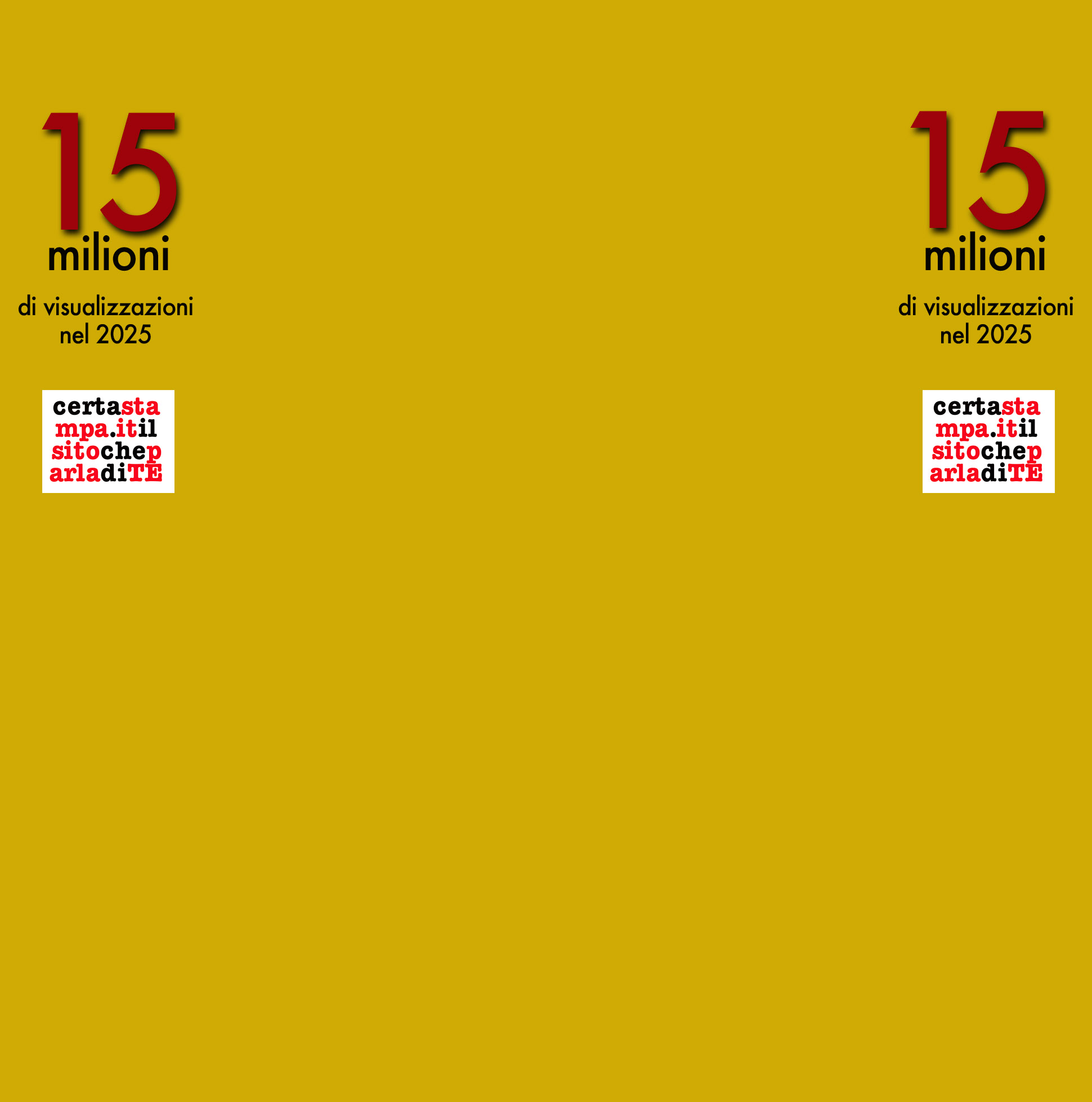E’ opera del giovane storicoteramano Gianmarco Cola, lo studio sulla lettera del vescovo di Teramo, Giovanni Antonio Campano, inviata nel 1465 al cardinale Iacopo Ammannati e riportata quasi per intero da Niccola Palma, che è stata e rimane a tutt’oggi una delle più importanti testimonianze relative alle condizioni della città e della diocesi aprutina alla metà del XV secolo.
E’ opera del giovane storicoteramano Gianmarco Cola, lo studio sulla lettera del vescovo di Teramo, Giovanni Antonio Campano, inviata nel 1465 al cardinale Iacopo Ammannati e riportata quasi per intero da Niccola Palma, che è stata e rimane a tutt’oggi una delle più importanti testimonianze relative alle condizioni della città e della diocesi aprutina alla metà del XV secolo.
Ecco lo studio, pubblicato su Zhistorica
di GianMarco Cola
Le notizie riferite nell’epistola, fatta eccezione per alcuni chiari artifici retorici, possono essere considerate veritiere o comunque altamente plausibili e dimostrano la profonda conoscenza che il religioso aveva della sua zona di competenza.
Fin dalle prime righe capiamo che la situazione non doveva essere particolarmente rosea, in quanto la città, pur definita “amoenissima, et pulcherrima”, si trovava in parte disabitata, a causa principalmente delle lotte interne tra fazioni, detta l’una dei “Mazzaclocchi”, l’altra degli “Spennati”, nonché delle devastazioni portate nel contado da varie compagini militari nel quadro della guerra Angioino-Aragonese per il controllo del trono di Napoli.
Data la sua importante posizione strategica infatti, a cavallo tra il regno di Napoli, lo Stato della Chiesa e le varie signorie marchigiane, il circondario di Teramo fu continuamente soggetto per tutto il Quattrocento al passaggio di eserciti, che come è ben noto procuravano danni ingenti a persone e proprietà.
Come l’antico nome romano della città, Interamnia, suggerisce, essa è posta alla confluenza di due fiumi, il Tordino e il Vezzola, che la circondano per tre lati ed hanno un’estrema importanza sia dal punto di vista economico che difensivo. Il Campano descrive poi il territorio che circonda la città e non manca di notare come questo benefici di una condizione climatica privilegiata, trovandosi esattamente a metà strada tra il Mar Adriatico e il massiccio del Gran Sasso, fatto che permette di evitare l’intenso caldo estivo come anche il pungente freddo invernale.
L’agglomerato urbano vero e proprio è circondato da mura, che il vescovo stima si estendano per circa tremila passi, sviluppandosi perlopiù in lunghezza che in larghezza, restringendosi verso sud-est in corrispondenza della confluenza fluviale.
Le vie interne sono lastricate in parte con mattoni, in parte a pietre e percorrono la città in lungo e in largo, da muro a muro e da porta a porta per tutta la grandezza della città, così bella da invitare al passeggio nei freschi giorni estivi. In questa splendida descrizione troviamo tipici abbellimenti di gusto letterario, con il nostro prelato umanista che dà alle strade cittadine una geometria che esse non hanno mai avuto: come fa notare il Palma nelle note relative alla lettera in realtà gran parte delle vie interne dei sestieri terminavano con una torre muraria, la cui difesa in caso di aggressione era adibita agli uomini abili della stessa.
Gli edifici tuttavia sono modesti e non molto alti, a causa delle durissime e pesanti pietre, provenienti dalle cave di Civitella del Tronto con le quali sono costruiti, difficili sia da trasportare che da squadrare; in realtà l’assenza di palazzi particolarmente elevati era dovuta alle continue distruzioni causate da decenni di lotte di fazione. Molto diffuse, come in ogni cittadina tardomedievale, sono le cappelle private appartenenti a singole famiglie, abbastanza ampie e lunghe ma non molto alte.
Spicca per imponenza la chiesa cattedrale, situata al centro della città e consacrata al culto della Vergine Maria, che viene descritta con dovizia di particolari iniziando dalla sua struttura, in parte in pietra in parte in laterizi, con la facciata sormontata da un elegante tetto a volta, sorretto da navate in legno con una copertura di tegole. L’edificio è inoltre dotato di tre magnifici portali, rivestiti di marmo, dei quali uno “accoglie il sole nascente”, ossia si apre verso est, l’altro “mostra il sole calante”, cioè l’ovest, mentre il terzo guarda a settentrione: questa descrizione è probabilmente la testimonianza più importante su come fosse la cattedrale di Santa Maria Assunta prima delle modifiche attuate nel XVIII secolo.
Il cardinale Ammannati è anche messo al corrente della presenza di resti architettonici di epoca romana, tra i quali spicca il teatro, che però il vescovo confonde con il più grande anfiteatro, la cui parete esterna è situata a pochissima distanza dalla Cattedrale e dal quale è stato inoltre prelevato gran parte del materiale usato per la costruzione dei vari edifici di culto cristiani nel corso dei secoli.
Il prelato descrive poi l’episcopio, ossia la sede patriarcale, che non spicca né per maestosità né per la bellezza delle stanze, ma ha una praticità e comodità unica, essendo separato dalla cattedrale solo da un vicolo; nel XVIII secolo i due luoghi di culto verranno collegati con il famoso Arco di Monsignore, abbattuto poi negli anni Sessanta del Novecento. La sede episcopale, quasi come una rocca isolata, si affacciava contemporaneamente sulle tre piazze più importanti della città, tutte consacrate ad attività commerciali di vario genere.
La prima piazza descritta non è altro che la platea trivii, probabile sede fin dalla ricostruzione cittadina del XII secolo di un mercato settimanale, confermato poi nel 1235, nel quale si vendevano oltre agli animali anche sale e metalli ed era spesso visitato da mercanti umbri e marchigiani. Il fatto che a Teramo già pochissimi anni dopo la guerra angioino-aragonese ci fossero ben tre piazze adibite a pratiche commerciali, delle quali la terza, chiamata anche platea magna, di discrete dimensioni, dimostra come la città avesse all’epoca una grande vitalità e non fosse stata del tutto annichilita dalle varie guerre e scorrerie. Ciò è anche confermato dalle successive parole del Campano, che dice:
Qualsiasi mezzo di trasporto o qualsiasi oggetto in vendita, dappertutto, arriva agli occhi, ritorna agli occhi e si propone allo sguardo. Perciò la comodità del vitto, se qualche capriccio si presenta, è vicina, e da lì queste cose possono essere acquistate. Si odono le vendite, strepitano, fremono le trattative, come si suole nei mercati.
All’analisi delle strutture e degli edifici si aggiunge quella della popolazione locale, per la quale le fonti di maggior guadagno sono l’industria della lana e appunto le attività commerciali: i teramani stessi secondo l’opinione del prelato casertano sono furbi e scaltri, le doti per eccellenza dei mercanti in ogni epoca, ma anche intelligenti e fieramente indipendenti e avversi alle tirannidi signorili, da cui si sono liberati recentemente, ma fedeli ai re della casa d’Aragona.
La tirannide qui accennata è la seconda dominazione di Giosia d’Acquaviva duca d’Atri, terminata nel 1461, pochi anni prima della stesura della lettera e che ebbe per conseguenza il ritorno di Teramo nel demanio reale e la cacciata della fazione dei “Mazzaclocchi”, sostenitori del potente nobile.
D’altronde gli oppositori di quest’ultimi, i cosiddetti “Spennati”, che il Savini chiama “fautori della patria libertà”, non avevano esitato a schierarsi in passato con l’Acquaviva quando si era trattato di prendere il potere. Non a caso il vescovo, toccando l’argomento della fedeltà dei cittadini verso il re di Napoli, scrive ironicamente che i teramani “non accettano altri, o annientano chi hanno accettato”, mostrando quindi di conoscere discretamente gli eventi dei decenni precedenti.
Tornando al rapporto tra il vescovo e la città, si nota come questo fosse del tutto originale rispetto al panorama italiano dell’epoca, dato che la curia vescovile conservava prerogative di origine feudale, come l’elezione di alcuni magistrati e la riscossione della trigesima, ossia la trentesima parte delle tasse che i cittadini pagavano per la partecipazione ai mercati locali.
Il vescovo aprutino poteva inoltre celebrare la messa indossando un’armatura e tenendo sull’altare armi bianche, fatto che rappresenta un caso unico in Italia. Questa tradizione era peraltro assai viva ancora alla metà del XVI secolo, tanto che al Concilio di Trento il vescovo aprutino di allora, Giovanni Silverii-Piccolomini, partecipò armato ad alcune funzioni religiose, suscitando vivo stupore.
Il nostro prelato casertano doveva poi gestire numerosi possedimenti che, pur essendo abbastanza estesi, circa una quarantina di villaggi e alcune fortificazioni, si trovavano per lo più nelle impervie zone montane; il vescovo si riservava infatti di nominare propri ufficiali, che sappiamo essere dueall’inizio del XVI secolo, i quali si occupavano sia delle cause civili che criminali e che riscuotevano le gabelle direttamente per conto della curia residente in città.
Dalla ricca descrizione dei domini territoriali sappiamo che vi abitassero poco meno di quattromila persone, di cui circa ottocento uomini adulti atti a portare armi in caso di bisogno, che vengono ironicamente definiti nella lettera “un esercito”.
Per la felicità degli storici successivi le condizioni di vita dei montanari, soggetti nei mesi invernali all’aspro clima appenninico, vengono illustrate con precisione e ricchezza di particolari. Essi beneficiano in gran parte dei feudi ecclesiastici di un suolo discretamente fertile che permette la coltivazione della vite e dell’ulivo, di gran lunga i prodotti più diffusi della zona, fin quasi ai contrafforti montani. Salendo di quota si incontrano pure dei villaggi, che però non hanno un’agricoltura particolarmente sviluppata, a causa del suolo improduttivo: i valligiani sopravvivono coltivando il grano in piccole quantità nei terreni più riparati tra le vette, oltreché cacciando e raccogliendo frutta, che riescono a trovare in grande abbondanza.
Il Campano in questa sezione della lettera ci dà preziose informazioni riguardo le sue abitudini residenziali: proprio come molti signori laici egli non risiede infatti in un unico luogo, ma spesso si sposta da una sede all’altra a seconda dei suoi bisogni, in parte seguendo il naturale corso delle stagioni. Con una bellissima metafora il prelato si paragona ai pastori dell’Abruzzo, che d’inverno si spostano verso il mare, dove egli possedeva una residenza, mentre in estate migrano sui monti, alla ricerca dei pascoli migliori per le loro pecore. Questo scorcio di vita pastorale non è solo una mera esaltazione della vita bucolica ma anche un’indiretta dimostrazione dell’importanza che l’allevamento ovino aveva nella zona, tanto che perfino un intellettuale umanista, quale era in fin dei conti il Campano, ne era rimasto colpito dopo solo pochi mesi di permanenza nel territorio.
Prima del termine dell’epistola vi è la descrizione di quello che probabilmente era il passatempo preferito dalle classi alte della società medievale e moderna: la caccia. I suoi feudi abbondano infatti sia di selve che di radure incolte, e sono pertanto popolati da una grande varietà di fauna selvatica, compresi cervi, cinghiali, lepri, volpi e numerosi tipi di volatili, come pernici, fagiani e tordi.
Il prelato aprutino mostra inoltre una certa esperienza in questa sua passione “secolare” e non si fa scrupolo di elencare all’amico cardinale le varie tecniche dei cacciatori, che si adattano di volta in volta all’animale, prevedendo spesso l’utilizzo di esche e cani da punta ma anche lo studio del volo degli uccelli: si notano qui chiare influenze di opere e trattati precedenti, su tutti il De arte venandi cum avibus di Federico II.
Viene descritto perfino l’uso di ripartire le prede dopo le varie battute, con le pelli donate a chi piazza le reti e le trappole, spesso contadini appartenenti al villaggio più vicino, mentre la carne viene divisa il più delle volte secondo il numero dei partecipanti alla caccia. Le pelli, oltre a poter essere conciate e vendute, erano fondamentali per la sopravvivenza delle popolazioni montane, soggette come già detto a inverni molto rigidi e che non avevano a disposizione larghi spazi atti alla coltivazione, sia per il terreno accidentato che per la scarsa fertilità del suolo.
Come nelle celebrazioni liturgiche la lettera ci informa che anche nella caccia al vescovo è concesso di poter incedere armato, con la lancia venatoria e vestito di porpora, privilegio che fin dai tempi romani è associato al massimo potere civile e militare; queste e altre caratteristiche uniche ed arcaiche dell’episcopato teramano erano con tutta probabilità dovute alle concessioni regie normanne della seconda metà del XII secolo, quando furono i vescovi a ricostruire la città dopo la sua distruzione nell’ambito delle guerre successive alla morte di Ruggero II di Sicilia.
Il Campano non risiedette spesso in Abruzzo dopo la sua nomina a vescovo della diocesi aprutina, morirà infatti nel 1477 a Siena, ma rimase profondamente legato al territorio, come dimostrano le bellissime descrizioni dell’epistola al cardinale Ammannati, le quali contribuiscono a formare un affresco raro ed assai affascinante sulla Teramo dell’epoca e sul potere rappresentato dal vescovo.
Pur ricorrendo a volte ad artifici retorici, egli ci dà preziose informazioni sulla vita economica e sociale sia dei cittadini che degli abitanti dei feudi ecclesiastici montani: non a caso infatti gran parte degli storici e cronisti teramani dei secoli seguenti, su tutti Muzio Muzii attingeranno a piene mani da questa epistola che il Palma riporta quasi integramente, saltando solo il proemio, nella sua Storia Ecclesiastica e Civile.