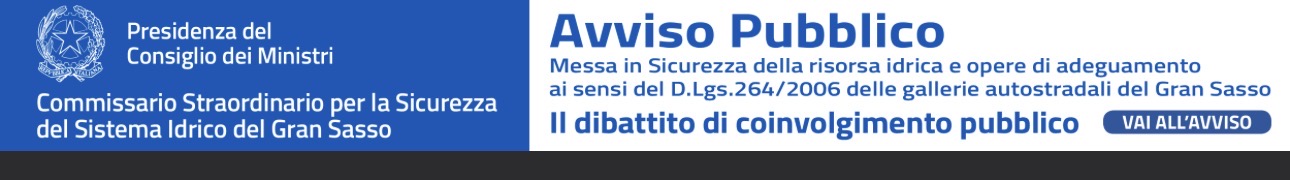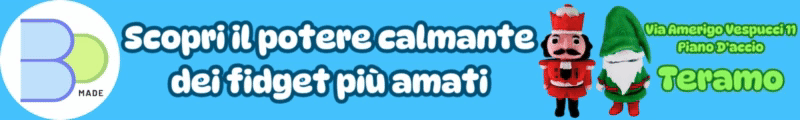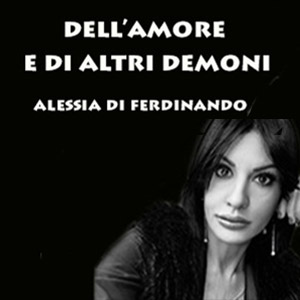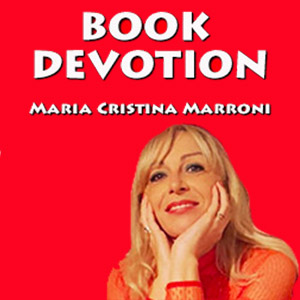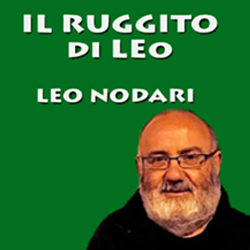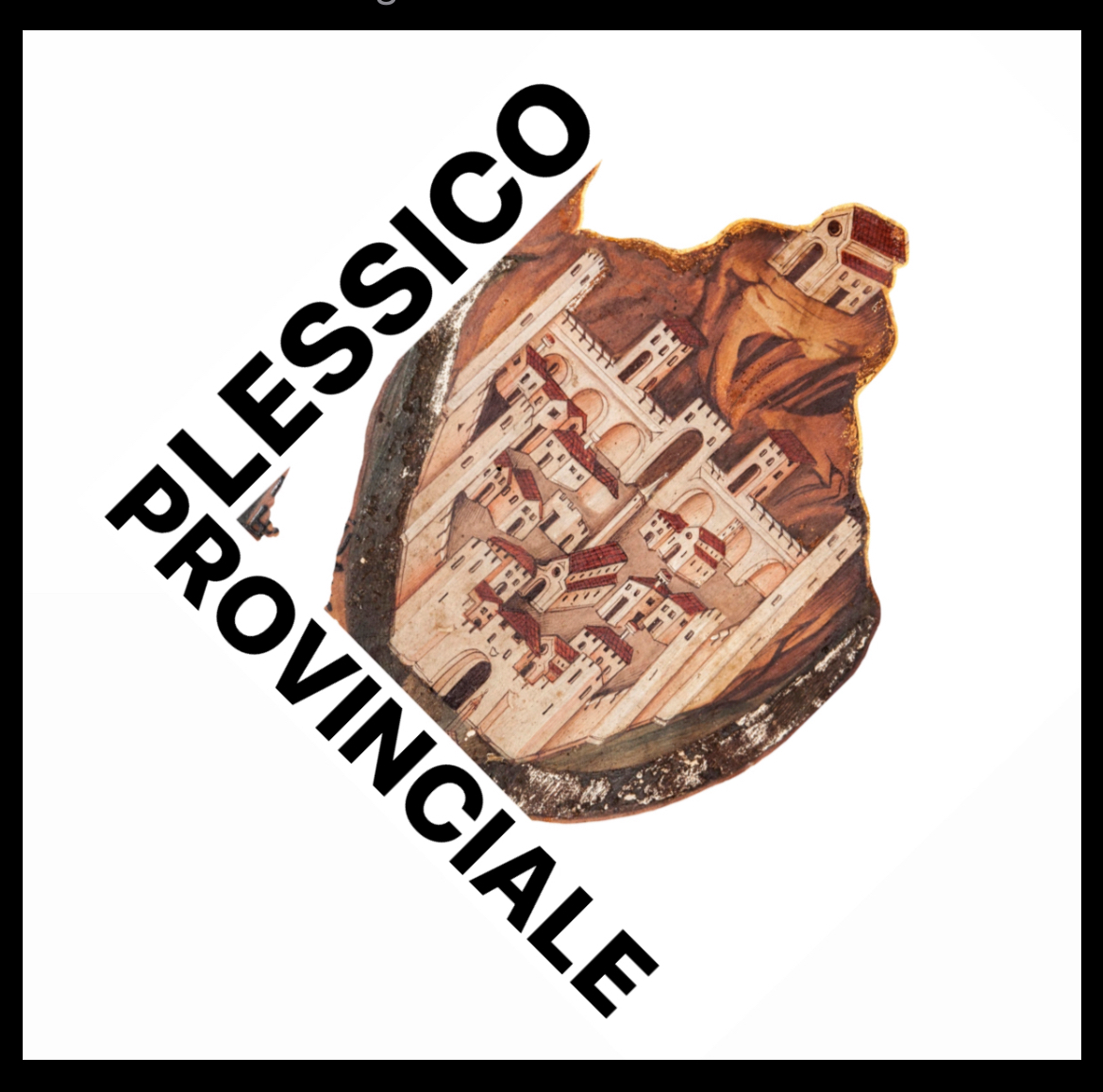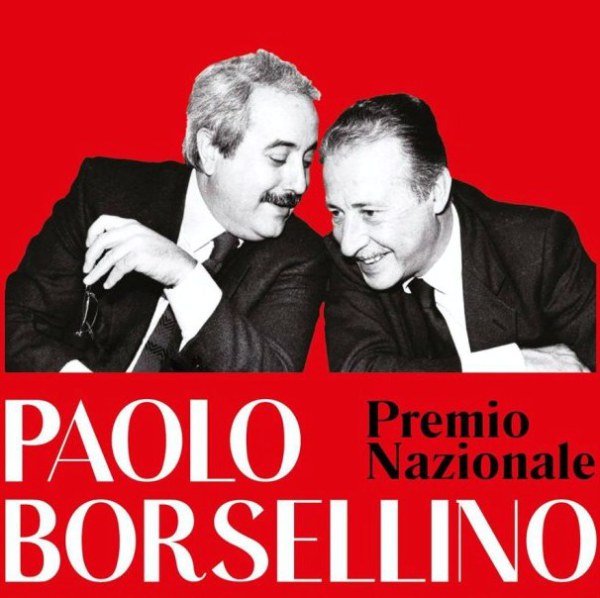Le estemporanee dichiarazioni del pur valido musicista Danilo Di Poalonicola, che, dopo aver preso a tutte e tre le edizioni della Notte dei Serpenti, ne ha preso le distanze rilasciando a “Il Centro” un’intervista in cui non risparmia alcune critiche (la principale delle quali è riassunta nel titolo “Notte dei Serpenti? Ok per la tv, ma non è la nostra tradizione”) e pone a modello alternativo “L’orchestra popolare del saltarello”, da lui portata come protagonista de “La Notte del Saltarello” (ma sembra che quest’anno si sia distanziato anche da quella), mi hanno fatto tornare alla mente un articolo pubblicato dalla “Rivista Abruzzese” (anno LXX, n. 3, luglio-settembre) a firma di Omerita Ranalli, ricercatrice presso l'Archivio Sonoro “Franco Coggiola”, studiosa di cultura contadina e di repertori musicali della tradizione orale, apprezzata autrice di saggi sulla poesia a braccio, sul canto sociale e sui canti tradizionali come fonti per la storia d'Italia.
Parlando dell’esibizione dell’Orchestra Popolare del Saltarello sul palco del 1° maggio di quell’anno in piazza San Giovanni a Roma (noto raduno della cultura di sinistra di ogni tendenza), la Ranalli avanzava più di una osservazione critica, arrivando a parlare di “Abruzzo tradito”. In che cosa consisteva il “tradimento”? Nell’aver trasformato gli aquilani, i marsicani, i peligni, i teramani, in salentini, un nuovo tipo di salentini, i “salentini d’Abruzzo”, “figli e nipoti della transumanza e di una buona dose di globalizzazione selvaggia”. Ma che cosa era accaduto? Era accaduto, scriveva la Ranalli, che da qualche anno il Festival del Saltarello, manifestazione itinerante estiva della provincia teramana, guardava alla Notte della Taranta nei suoi aspetti spettacolari e di massa, ma rischiava di confondere in maniera irreversibile il panorama, già confuso, delle musiche di tradizione orale che negli ultimi secoli avevano avuto la loro diffusione nei territori della regione Abruzzo. Anche l’Abruzzo era così vittima del triste fenomeno del “neo tarantismo”, senza che nella regione vi fosse stata quella ricerca negli archivi che sola avrebbe potuto portare ad una “patrimonializzazione” di elementi culturali musicali. Il Festival del Saltarello era, insomma, orfano della ricerca, che, sola, avrebbe potuto conferirgli elaborazione, critica e contesto. Al di là della storia che accomunava la Puglia e l’Abruzzo, con innegabili collegamenti e contaminazioni, con il comune assai diffuso ricorso all’organetto a due o quattro bassi, finito poi nell’uso quasi esclusivo di un organetto a otto bassi in sol/do, il Festival del Saltarello aveva trasformato il saltarello abruzzese in una neo-pizzica, avendo assunto del popolare ballo salentino forma e struttura, che nel concerto romano del ° maggio aveva finito per rappresentare un Abruzzo ferito e tradito.
La Regione Abruzzo, ricordava la Ranalli nel suo articolo del 2017, aveva promosso, in collaborazione con le università abruzzesi, un corso di perfezionamento sulle culture musicali regionali e sulla loro restituzione, il progetto Al.Fo. «per il recupero e la valorizzazione di risorse e tradizioni musicali abruzzesi, nella prospettiva di un maggiore sviluppo delle politiche turistiche regionali». Il corso aveva dato ampio spazio a queste tematiche attraverso l’attivazione di moduli specifici sulle musiche di tradizione orale, sugli archivi, sull’etnomusicologia, sulla sociologia del turismo musicale. Ciò nonostante, le politiche culturali regionali avevano guardato esclusivamente al modello spettacolare, rischiando, scriveva la Ranalli, di creare una nuova drammatica frattura tra le musiche della tradizione e il loro studio da una parte, e la diffusione acritica di fenomeni musicali di massa in cui si offriva ad un pubblico sempre più incolto un calderone di ritmi, suoni e immagini contaminate, ma spacciate per autentiche, popolari, tradizionali dall’altra, proposte all’interno di manifestazioni ufficiali finanziate con fondi pubblici e promosse attraverso tutti i canali istituzionali”. Nel frattempo, una proposta di legge regionale sulla salvaguardia delle culture tradizionali era ferma dal 2014, rinviata da una commissione all’altra. Le elezioni del 2014 erano state quelle che avevano portato alla presidenza della Regione Abruzzo Luciano D’Alfonso e avevano segnato il trionfo di quella sinistra che oggi, così come D’Alfonso, si permette di criticare la “Notte dei Serpenti” (solo perché patrocinata dalla destra di Marsilio), che è riuscita a scongiurare proprio i pericoli che la Ranalli individuava come esiziali nella preparazione dei grandi eventi: la totale mancanza di una prospettiva culturale che legittimasse un dispendio di soldi pubblici.
“La Notte dei Serpenti” è stata il risultato finale di una meticolosa ricerca di testi, musiche popolari tradizionali e di autore, di una elaborazione critica e di una rivisitazione musicale finalizzata a conferire ai canti della tradizione una veste più moderna e più accattivante, ma mai scimmiottando la pizzica salentina e mai “salentinizzandosi”, e conservando l’autenticità della nostra tradizione regionale. “La Notte dei Serpenti” ha realizzato (e sia le prove nel Teatro Comunale di Atri, sempre frequentatissime, che l’ampia partecipazione di popolo e del pubblico televisivo lo hanno dimostrato), quella che la Ranalli nel 2017 riteneva fosse solo “un’unica, flebile, speranza”: che ad una un’elaborazione critica dall’alto si aggiungesse una partecipazione culturale dal basso, da cui sarebbe potuta rinascere e svilupparsi l’attenzione alle complesse questioni dei patrimoni culturali da difendere con le armi dello studio e della ricerca, per una “riproposta” che rendesse merito alla storia da cui proveniamo. In alternativa, diceva la Ranalli, agli abruzzesi sarebbero restati solo gli arrosticini. Per fortuna, “La Notte dei Serpenti” ci ha dato tanto altro.
Elso Simone Serpentini