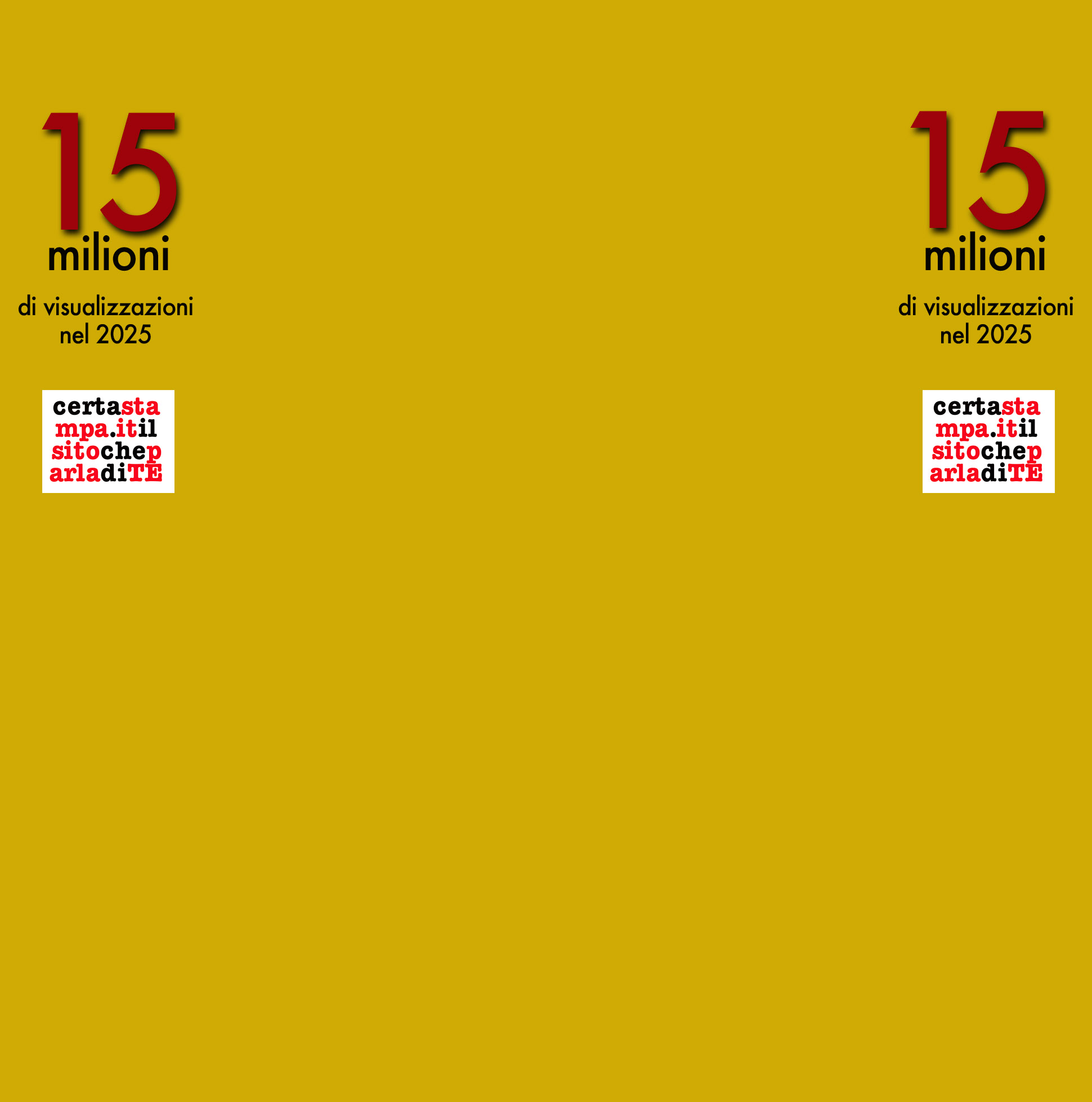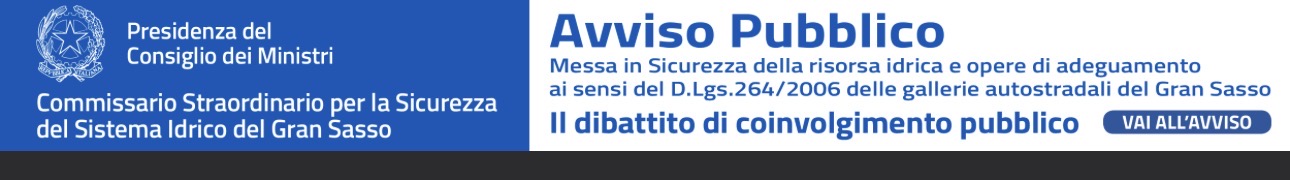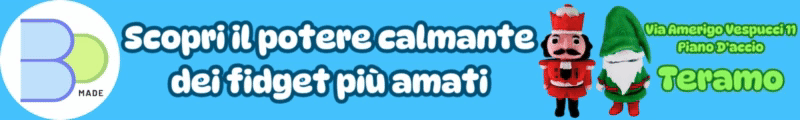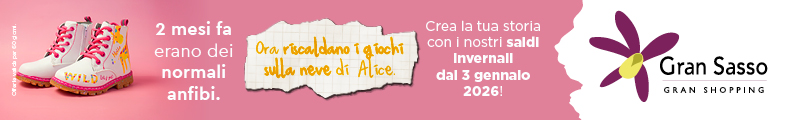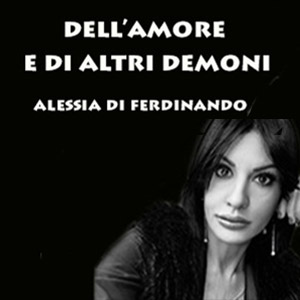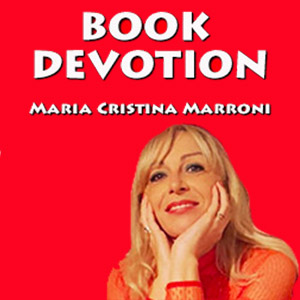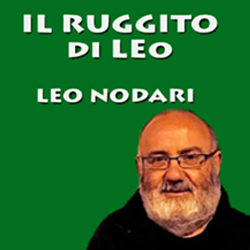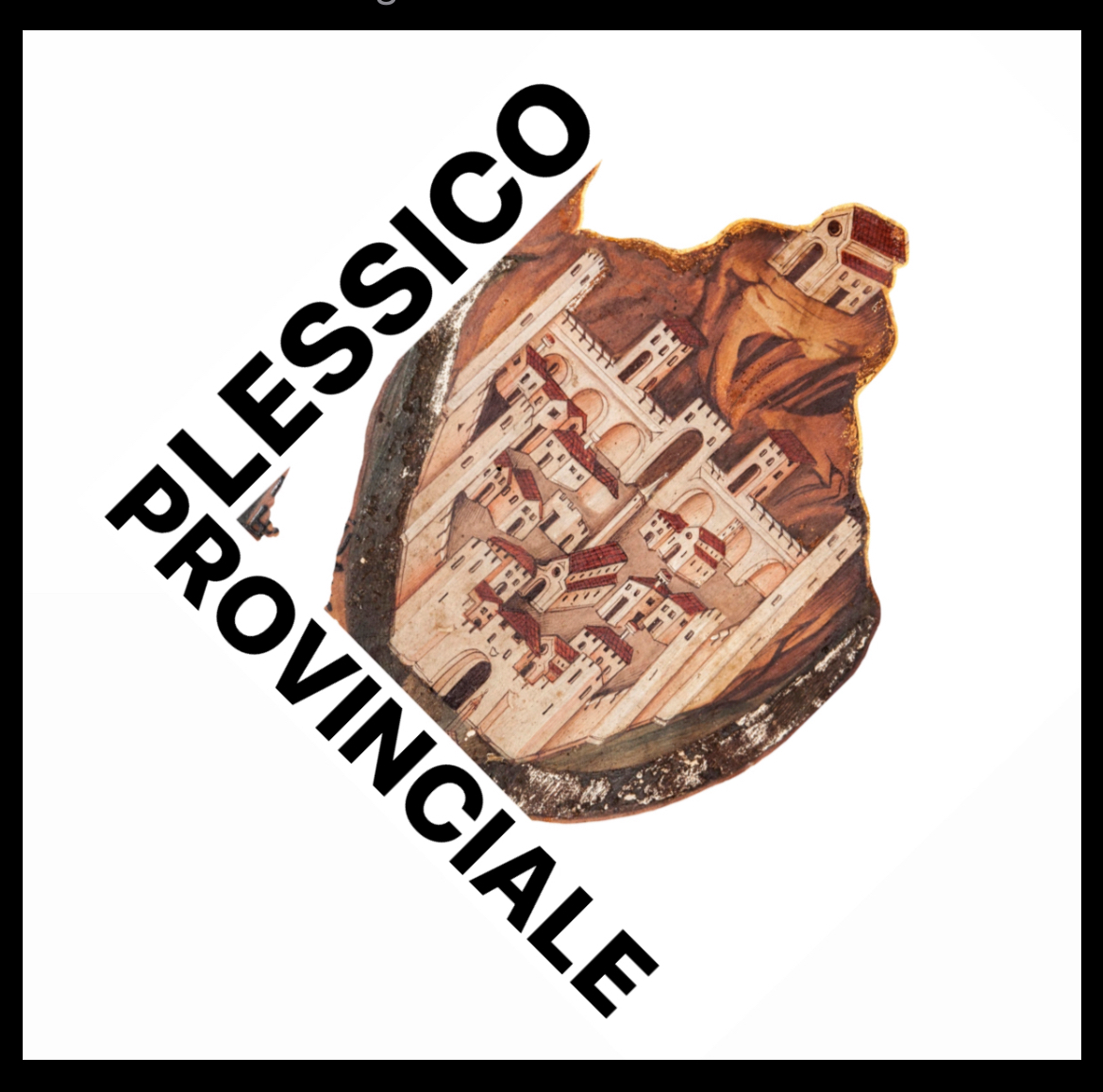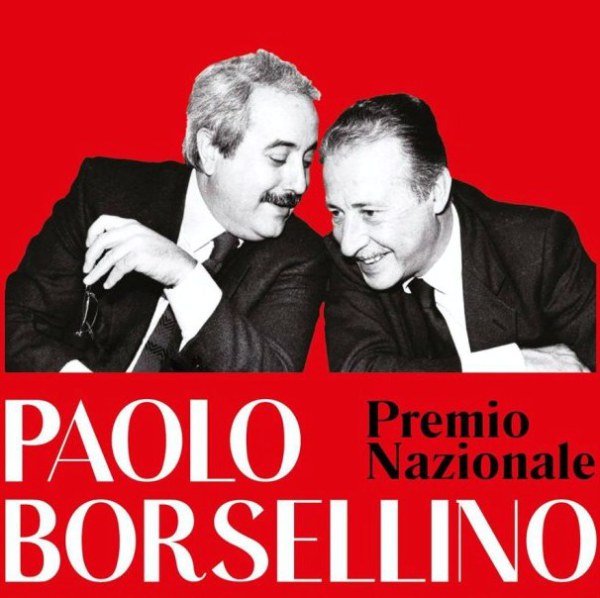Le difficoltà economiche per accedere all'energia sono e saranno causa di gravi ripercussioni sul benessere e sulla salute dei cittadini europei e italiani.
Le difficoltà economiche per accedere all'energia sono e saranno causa di gravi ripercussioni sul benessere e sulla salute dei cittadini europei e italiani.
Dopo un inverno difficile per molti europei, l'estate in arrivo porterà nuove sfide.
I problemi legati alla povertà energetica non scompariranno con il caldo, anzi, rischiano di intensificarsi. La stagione estiva porterà con sé la persistenza delle criticità legate alla povertà energetica, che potrebbero acuirsi con l'aumento delle temperature.
Come rilevato dal Rapporto sullo stato del clima redatto dalla World Metereological Organization, in sinergia con il Servizio per il cambiamento climatico Copernico dell’Unione Europea, negli ultimi 30 anni si è assistito ad un innalzamento progressivo delle temperature costante e repentino (1).
Ma facciamo un passo indietro, precisando cosa si intende per “povertà energetica”.
L’ *OIPE* , nell’ultimo Rapporto presentato alla Camera dei Deputati, avente ad oggetto la “Povertà energetica e impatto di genere” (2), richiama la definizione generale a livello europeo fornita in via definitiva dalla Direttiva (UE) 2023/1791 (direttiva sull’efficienza energetica, c.d. EED 3), che all’articolo 2 così recita:
*La Povertà Energetica è: “l’impossibilità per una famiglia di accedere a servizi energetici essenziali che forniscono livelli basilari e standard dignitosi di vita e salute, compresa un’erogazione adeguata di riscaldamento, acqua calda, raffrescamento, illuminazione ed energia per alimentare gli apparecchi, nel rispettivo contesto nazionale, della politica sociale esistente a livello nazionale e delle altre politiche nazionali pertinenti, a causa di una combinazione di fattori, tra cui almeno l’inaccessibilità economica, un reddito disponibile insufficiente, spese elevate per l’energia e la scarsa efficienza energetica delle abitazioni* ”.
E’ evidente che si tratta di una condizione che mina l'inclusione sociale e minaccia il benessere dei cittadini italiani ed europei.
La lotta alla povertà energetica, perciò, non è solo un imperativo di giustizia sociale, ma si configura come un passaggio cruciale e ineludibile per raggiungere l'ambizioso traguardo europeo della neutralità climatica entro il 2050.
La persistente vulnerabilità di alcuni segmenti della popolazione è con tutta evidenza esacerbata dalle disparità socioeconomiche e dalle inefficienze nei consumi energetici e abitativi ed è un dato di fatto in tutti i paesi dell'UE, seppur con differenze notevoli tra Stato e Stato, come rilevato dal Rapporto dell’Unione Europea del 2024 (3).
*QUAL E’ LA SITUAZIONE IN ITALIA?*
Secondo quanto riportato dal *rapporto congiunto ISTAT e ARERA del 2024* (cfr. pp. 4-5), la povertà energetica persiste come problematica di grande rilevanza per il tessuto socio-economico italiano. Le più recenti elaborazioni statistiche evidenziano che circa 3,2 milioni di nuclei familiari in Italia si trovano tuttora in una condizione di grande vulnerabilità rispetto alla capacità di far fronte alle spese energetiche.
Il principale strumento di supporto statale, rappresentato dal Bonus Sociale, ha visto un ulteriore potenziamento nel corso del 2024, che si è concretizzato principalmente attraverso l'incremento della soglia ISEE per l'ammissibilità agli sconti, portata a 15.000 euro, l'introduzione di criteri di accesso più inclusivi destinati a famiglie con membri in condizioni di fragilità e la semplificazione della procedura di richiesta tramite l'automazione attraverso la piattaforma INPS.
*LIMITI DELL'INTERVENTO PUBBLICO E STRUMENTI A CONFRONTO: EFFICACIA E SFIDE NEL CONTRASTARE LA POVERTÀ ENERGETICA*
Il panorama degli interventi contro la povertà energetica in Italia presenta, tuttavia, oggi un quadro complesso e profondamente contraddittorio che nasconde una realtà ben più articolata, in cui gli sforzi governativi spesso risultano inadeguati rispetto alla complessità del problema.
Il Bonus Sociale, presentato come strumento risolutivo, ha rivelato infatti numerose criticità.
I criteri di accesso, apparentemente inclusivi, escludono di fatto ampie fasce di popolazione che versano in condizioni di difficoltà. La soglia ISEE, ferma a 15.000 euro, rappresenta un limite artificioso che non coglie la vera complessità della vulnerabilità economica contemporanea. Molte famiglie che si trovano appena sopra questa soglia vengono sostanzialmente abbandonate a se stesse, costrette a fronteggiare costi energetici sempre più proibitivi.
L'entità degli aiuti si configura più come un palliativo che una soluzione strutturale. I contributi attuali appaiono del tutto insufficienti rispetto all'incremento dei costi energetici, configurando un sostegno più simbolico che realmente risolutivo e la mancanza di una rivalutazione dinamica degli interventi rispetto all'inflazione accentua ulteriormente questo divario.
La frammentazione territoriale rappresenta un altro nodo cruciale.
Le differenze tra gli interventi nelle regioni del Nord e del Sud Italia tradiscono l'assenza di una strategia nazionale organica. Gli interventi sembrano più dettati dall'emergenza che da una visione strategica di medio-lungo periodo, rivelando l'approccio sostanzialmente emergenziale delle istituzioni.
L'efficientamento energetico, presentato come la grande soluzione, si scontra con barriere economiche e burocratiche significative. I costi iniziali degli interventi di riqualificazione restano proibitivi per le famiglie a basso reddito. L'accesso al credito rimane difficoltoso e gli incentivi appaiono inadeguati rispetto all'investimento richiesto. La complessità burocratica aggiunge, poi, un ulteriore livello di difficoltà, scoraggiando di fatto molti cittadini dal percorrere strade di miglioramento energetico.
Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonostante le premesse, stenta a decollare con l'efficacia sperata. I ritardi nell'implementazione, lo scarso coordinamento tra obiettivi nazionali e realtà locali, la limitata capacità di coinvolgimento delle comunità territoriali rappresentano altrettanti elementi di debolezza.
Gli interventi attuali, pur rappresentando perciò un primo passo importante, evidenziano limiti strutturali significativi. Serve un cambio di paradigma che consideri la povertà energetica non come un problema emergenziale, ma come una sfida sistemica che richiede risposte organiche e di lungo periodo.
(1) https://wmo.int/publication-series/state-of-climate-europe
(2) https://temi.camera.it/leg19/dossier/OCD18-20406/poverta-energetica-e-impatto-genere.html
(3) The persistence of energy poverty in the EU- Socioeconomic insights into EU's long-term energy poverty - https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/95ece8a0-6100-11ef-a8ba-01aa75ed71a1/language-en
(4) https://oipeosservatorio.it/2024/05/29/elementor-3298/#:~:text=conferma%20la%20stima%20di%202,per%20ridurre%20caro%20energia)%3B
(5) https://www.consumersforum.it/in-evidenza/5593-arera-relazione-annuale-2024.html