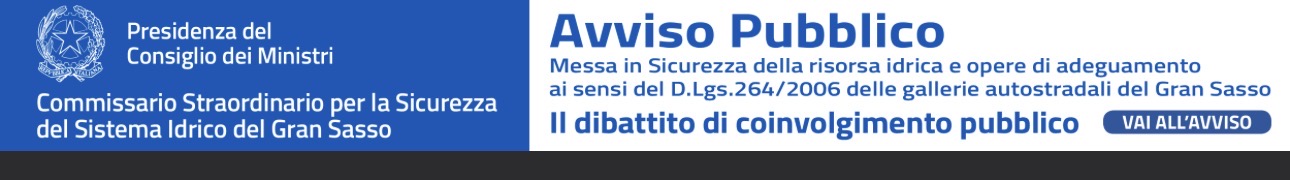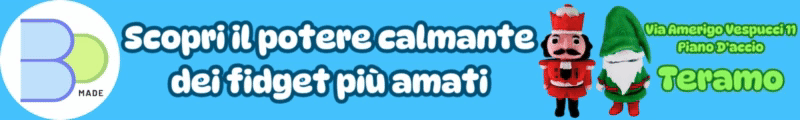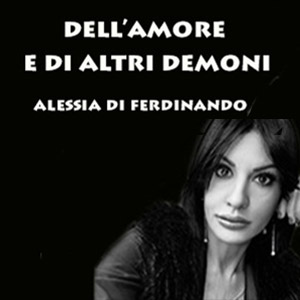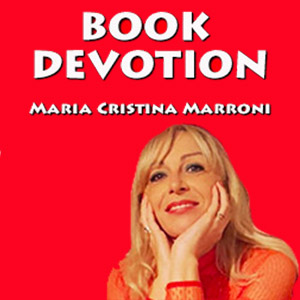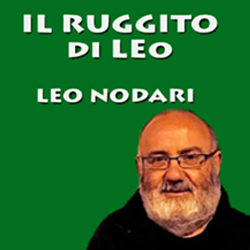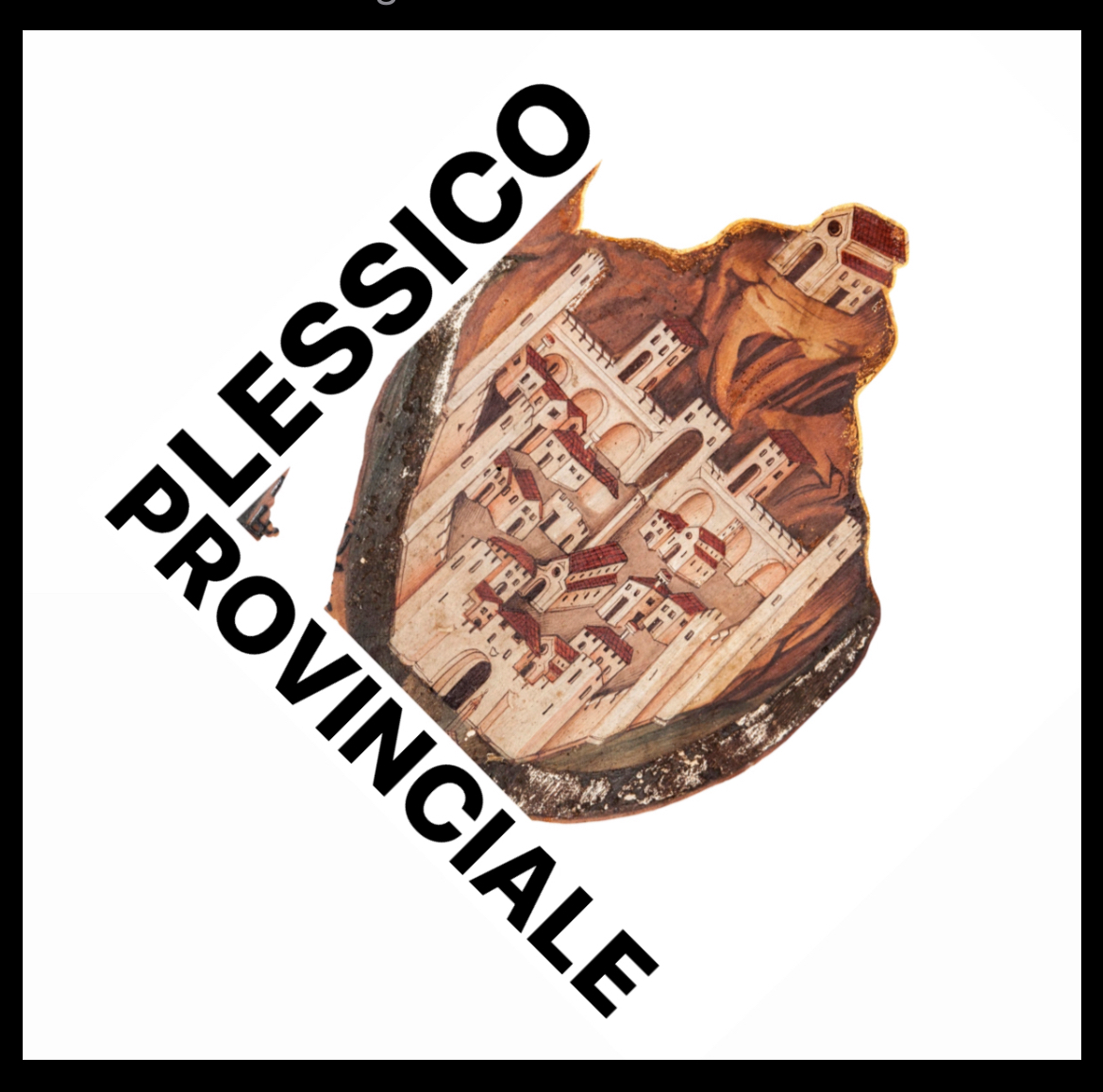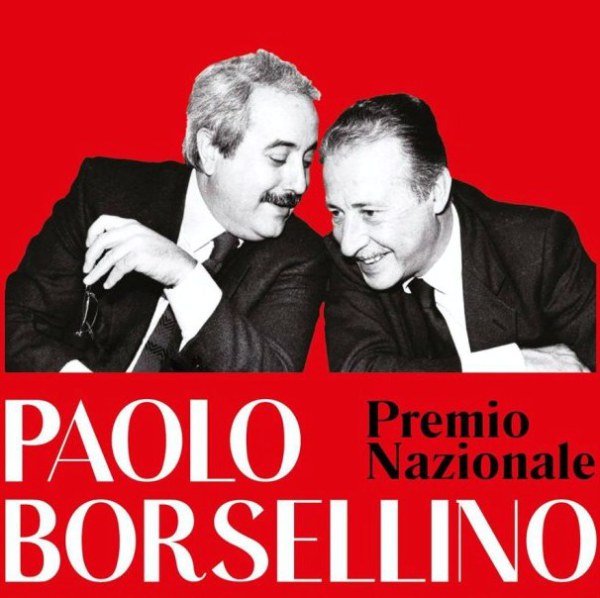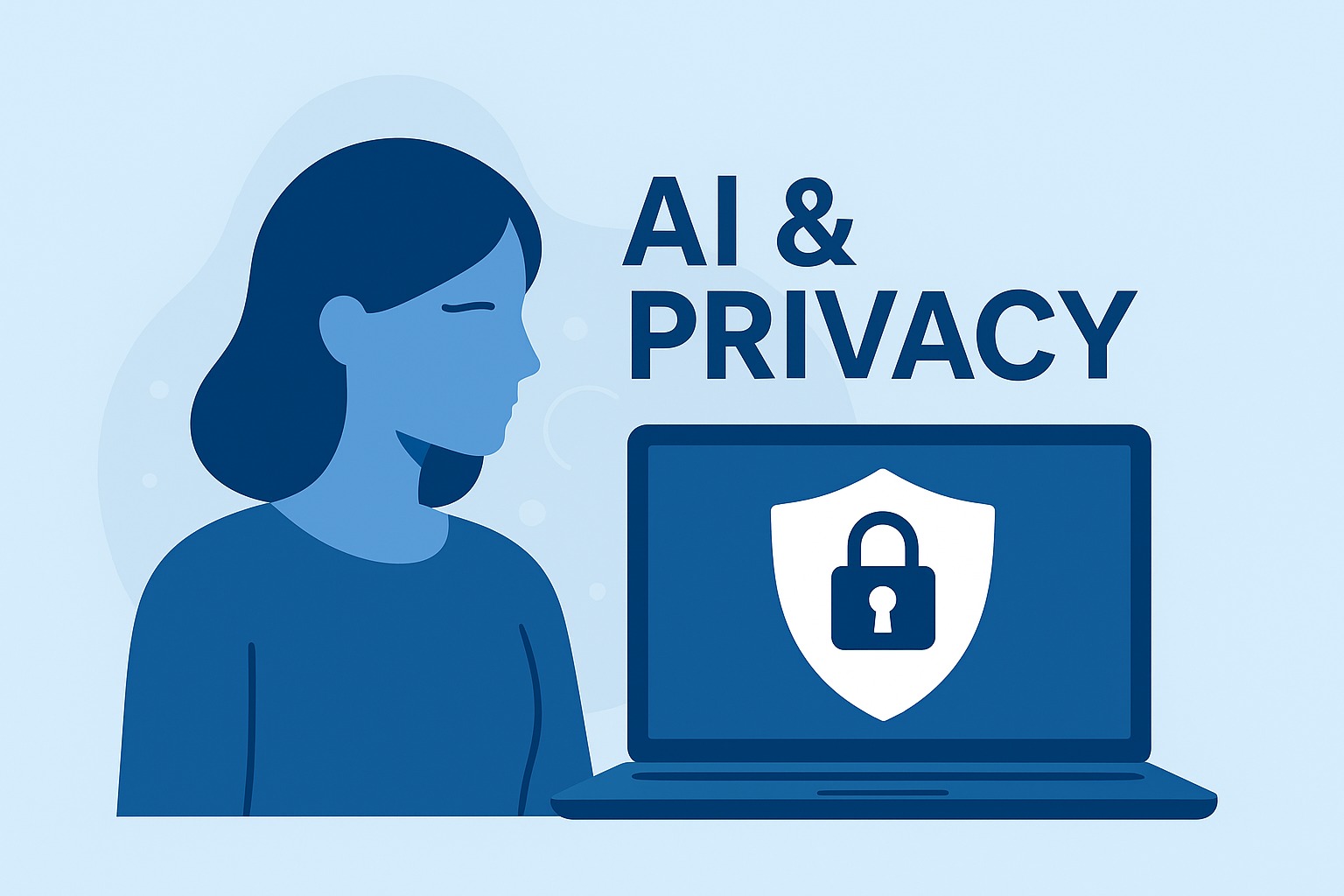
*AI e privacy: il confine invisibile*
*Proteggerci o osservarci? L’Europa prova a riscrivere le regole della sicurezza digitale.*
Negli ultimi anni, l’Unione Europea ha posto al centro del dibattito politico e tecnologico la protezione della privacy e dei dati personali.
Dal GDPR all’AI Act e al Digital Services Act (DSA), le normative mirano a disciplinare l’uso dell’intelligenza artificiale e dei servizi digitali ad alto impatto.
L’obiettivo dichiarato è duplice: tutelare i cittadini e garantire un ecosistema digitale sicuro e affidabile.
Ma dietro la promessa di tutela si nasconde una domanda cruciale: fino a che punto la protezione della privacy può trasformarsi in sorveglianza di massa?
*Le nuove regole europee sull’IA*
Prima di tutto, occorre precisare che il Regolamento sull’Intelligenza Artificiale (AI Act), entrato in vigore il 1° agosto 2024, classifica i sistemi Intelligenza Artificiale in quattro categorie di rischio:
*1.* *INACCETTABILE* – vietati sono ad esempio i sistemi come il punteggio sociale (social scoring statale), o manipolazioni comportamentali su minori e la sorveglianza di massa, che minacciano i valori fondamentali dell'UE e i diritti umani.
Per sistema di punteggio sociale si fa riferimento a quei sistemi che assegnano un punteggio ai cittadini sulla base della propria condotta (dal pagare le multe al comportamento online) che determina conseguentemente un punteggio. Un punteggio elevato può sbloccare privilegi (es. prestiti agevolati), mentre un punteggio basso può imporre restrizioni (es. limitazioni ai trasporti o al lavoro). Dato che questi sistemi influenzano l'accesso a risorse e opportunità ledendo potenzialmente i diritti fondamentali, l'UE ne impone il divieto assoluto.
*2.* *ALTO RISCHIO* – soggetti a requisiti stringenti di trasparenza, sicurezza e valutazione dell’impatto sui diritti fondamentali.
Questa categoria comprende una vasta gamma di sistemi di IA che, a causa del loro impatto potenziale, potrebbero causare danni significativi in caso di guasto o malfunzionamento.
Rientrano in questo gruppo:
• Sistemi biometrici (es. identificazione e riconoscimento facciale).
• Sistemi di valutazione del credito e scoring.
• Chatbot medici che forniscono diagnosi.
• Sistemi di guida autonoma.
Un esempio specifico è l'uso di sistemi di riconoscimento facciale per la sorveglianza in tempo reale in luoghi pubblici (come stazioni o aeroporti). Sebbene un tale sistema possa aiutare le forze dell'ordine a identificare e intercettare rapidamente individui ricercati, il suo utilizzo è permesso solo nei termini strettamente previsti dalle norme. Questo serve a bilanciare la sicurezza con la protezione dei diritti individuali.
*3. RISCHIO LIMITATO* – obblighi minimi di trasparenza (ad esempio notificare quando si interagisce con un’IA).
Questa categoria include tutti i sistemi di IA che, per loro natura, presentano un rischio intrinsecamente minore di causare danni. Nonostante il basso impatto, devono comunque aderire a principi di trasparenza e robustezza.
Sono esempi tipici i Chatbot generici di assistenza ed i Software base di elaborazione delle immagini.
Ci si imbatte ormai di frequente in chatbot di supporto clienti progettato unicamente per rispondere a domande comuni (come orari o politiche di reso): in questo caso il rischio è limitato poiché il sistema non gestisce dati sensibili o personali, ed i rischi per la privacy e l'etica sono contenuti.
Un altro caso è quello relativo ai software per l'ottimizzazione di immagini che regolano automaticamente elementi come luminosità e contrasto per migliorare la qualità delle foto dei prodotti. Anche in questo caso, tali tipologie di software non identificano né memorizzano volti o altre informazioni personali, e per questo rientrano nella categoria di rischio limitato.
In sintesi, per questi strumenti meno invasivi, la regolamentazione si concentra sul garantire che l'utente sia informato e che il sistema funzioni in modo affidabile, senza imporre gli oneri rigidi previsti per le categorie a rischio maggiore.
*4. RISCHIO MINIMO*
Questa categoria comprende i sistemi di IA che hanno un impatto minimo o nullo sulla sicurezza, sui diritti e sulle libertà delle persone. Di conseguenza, sono esentati dalla maggior parte degli obblighi rigorosi previsti dall'AI Act.
Sono esempi tipici gli strumenti di calcolo (come una calcolatrice basata su IA per smartphone) e le applicazioni per videogiochi semplici. O anche la comune app per la gestione della lista della spesa. La funzione di quest’ultima, infatti, si limita ad aiutare l'utente a organizzare gli acquisti e impostare promemoria. Poiché non elabora dati personali sensibili il rischio per la privacy o la sicurezza è virtualmente assente. Il suo scopo è puramente organizzativo e non incide su decisioni o attività di rilevanza critica nella vita dell'utente.
*I punti critici*
Nonostante le apprezzabili intenzioni di regolamentare l'Intelligenza Artificiale a tutela dei cittadini, il percorso verso l'applicazione di questa normativa presenta tuttavia diverse criticità e tensioni che meritano attenzione.
Una delle sfide più delicate riguarda la sorveglianza preventiva: l'obbligo per alcune piattaforme di implementare sistemi di filtraggio e controllo dei contenuti potrebbe facilmente sconfinare nell'interferenza con la privacy degli utenti, generando preoccupazioni sulla libertà di comunicazione e l'anonimato. Parallelamente, si acuisce il conflitto tra l'esigenza di trasparenza richiesta dalla legge e la necessità di proteggere il segreto industriale delle aziende; molte ritengono infatti che divulgare i dettagli sul funzionamento dei loro algoritmi pregiudichi la loro proprietà intellettuale.
Inoltre, risulta ancora ambigua la definizione di "alto rischio".
L'interpretazione di cosa costituisca un rischio significativo non è sempre chiara e lascia spazio a decisioni discrezionali da parte delle autorità nazionali, il che potrebbe portare a un'applicazione della norma frammentata e disomogenea all'interno dell'Unione Europea.
A ciò si aggiunge il problema dei costi di conformità elevati: le rigorose valutazioni, i test e gli audit imposti dall'AI Act rischiano di rappresentare una barriera insormontabile per startup e PMI, limitando di fatto la loro capacità di innovare e accedere al mercato europeo, favorendo potenzialmente solo le grandi aziende con maggiori risorse.
*Gli aspetti positivi dell’intervento europeo*
Nonostante le difficoltà e le sfide applicative che la regolamentazione dell'intelligenza artificiale comporta, l'intervento normativo dell'Unione Europea offre una serie di benefici concreti fondamentali per il futuro digitale.
Innanzitutto, l'AI Act garantisce una solida tutela dei cittadini.
Stabilendo regole chiare, la normativa mira a proteggere gli individui dai rischi più gravi derivanti dall'IA, come le discriminazioni automatizzate, la profilazione illegittima e le manipolazioni comportamentali che minacciano i diritti fondamentali.
Questa maggiore protezione contribuisce direttamente a un significativo aumento della fiducia nell’IA.
I requisiti di trasparenza e i controlli obbligatori sui sistemi digitali rendono le tecnologie più sicure e prevedibili. Quando gli utenti e le aziende sanno che l'IA opera entro limiti ben definiti e sottoposta a verifica, sono più propensi ad adottarla in modo responsabile e a integrarla nella loro vita e nei processi lavorativi.
Inoltre, l'Unione Europea si posiziona come leadership globale nella regolamentazione digitale. Attraverso questa legislazione l'UE stabilisce di fatto standard che hanno il potenziale di influenzare legislazioni in tutto il mondo, promuovendo a livello internazionale valori come la sicurezza, la privacy e i diritti digitali.
Infine, la regolamentazione incentiva l'innovazione sostenibile. Focalizzarsi sulla regolamentazione dell'IA ad alto rischio spinge le aziende non solo a innovare, ma anche a sviluppare tecnologie che siano intrinsecamente affidabili e sicure. Invece di una corsa sregolata, la legge incoraggia lo sviluppo di soluzioni di IA che siano responsabili fin dalla loro progettazione.
*Reazioni e dibattito*
Nonostante le intenzioni positive dell’Unione Europea nel voler regolamentare l’intelligenza artificiale a tutela dei cittadini, l’intervento normativo presenta pero’ diversi aspetti critici che rischiano di ostacolare l’innovazione e la competitività del settore digitale europeo.
In primo luogo, la complessità e i costi elevati di conformità imposti dall’AI Act rappresentano un serio ostacolo per startup e piccole e medie imprese, che spesso non dispongono delle risorse necessarie per affrontare audit, test e procedure di valutazione richieste. Ciò potrebbe tradursi in una concentrazione del mercato a vantaggio delle grandi aziende, riducendo la diversità e la dinamicità dell’ecosistema tecnologico.
Inoltre, l’obbligo di trasparenza sui meccanismi interni dei sistemi di IA pone le imprese di fronte al dilemma tra rispetto delle normative e tutela del proprio know-how, minacciando la riservatezza del segreto industriale.
Un ulteriore elemento di criticità riguarda l’ambiguità nella definizione di “alto rischio”, che lascia spazio a interpretazioni soggettive e a un’applicazione disomogenea tra i vari Stati membri, rischiando di creare incertezza normativa e disparità di trattamento.
Infine, il rafforzamento dei sistemi di monitoraggio e filtraggio dei contenuti digitali, pur finalizzato alla sicurezza, solleva timori legittimi di sorveglianza generalizzata e di compressione delle libertà individuali, mettendo in discussione il delicato equilibrio tra protezione e controllo.
In Italia il Garante per la Privacy italiano ha sottolineato l’importanza di conciliare sicurezza, innovazione e libertà individuale, ricordando che le normative europee possono rappresentare un modello di tutela globale se applicate correttamente.
L’Europa punta a diventare regolatore globale dell’innovazione digitale, con la finalità principale di proteggere i cittadini dai rischi dell’IA e incentivando pratiche responsabili. Tuttavia, il confine tra protezione dei dati e sorveglianza resta labile, se non integrato da un’implementazione attenta delle normative europee e nazionali che può rappresentare uno strumento efficace di tutela e innovazione sostenibile, capace di garantire sicurezza, fiducia e libertà nell’ecosistema digitale.
Fonti:
Agenda Digitale – AI Act
Digital Strategy EU