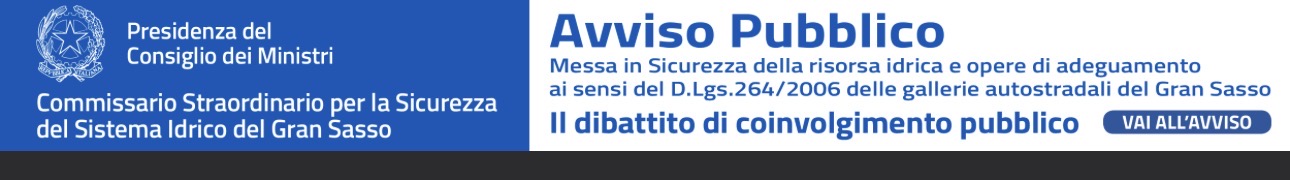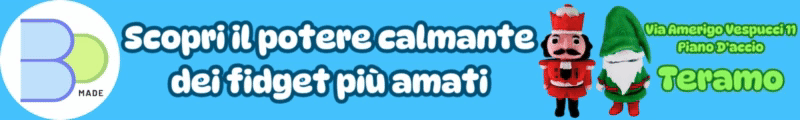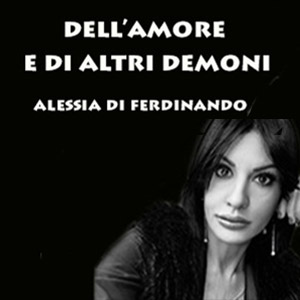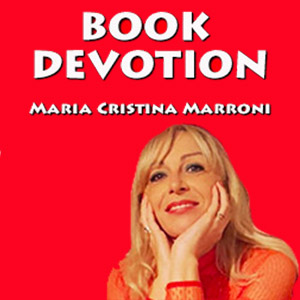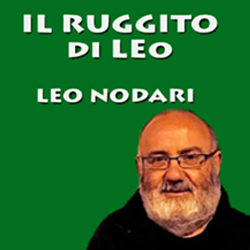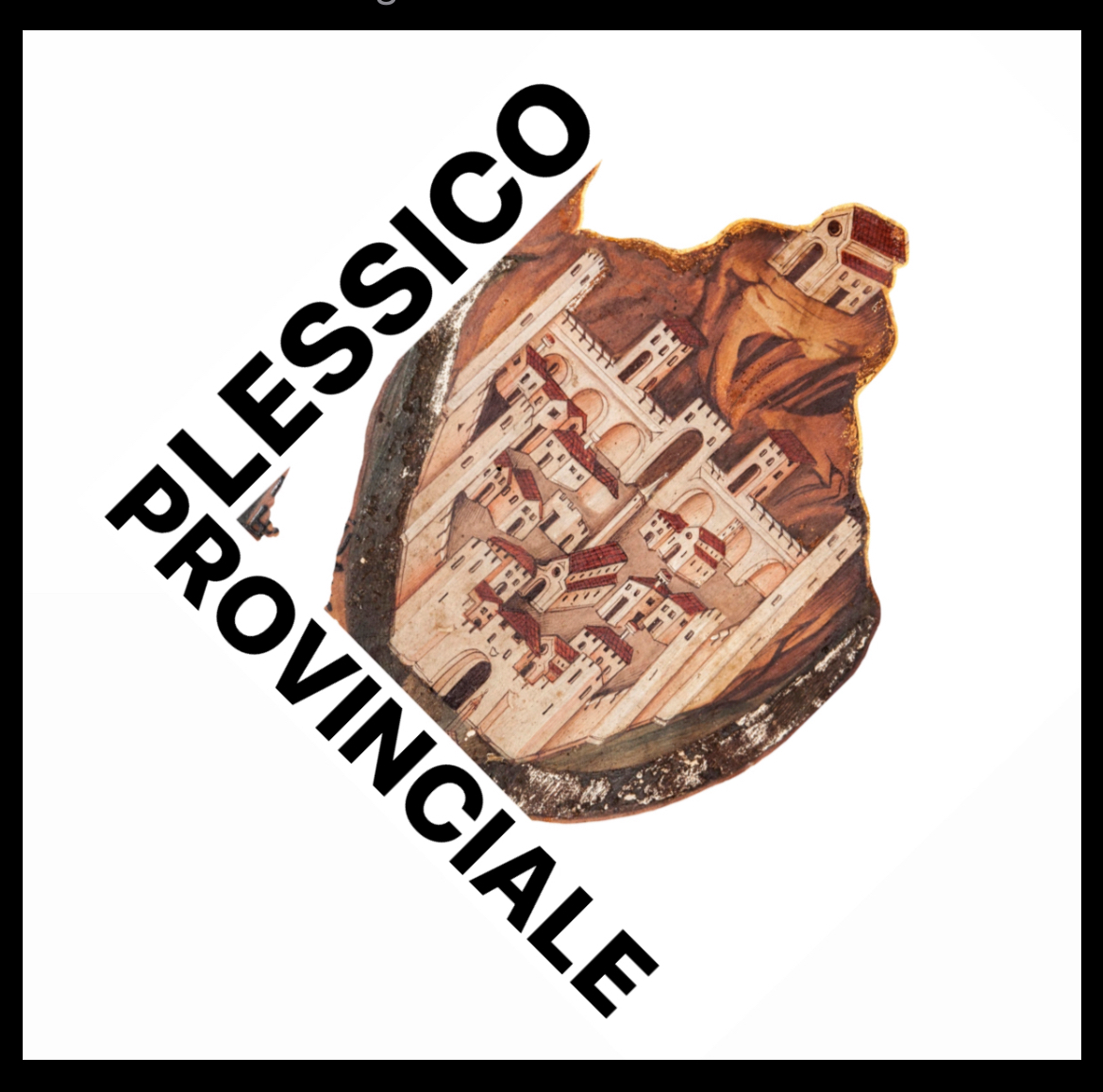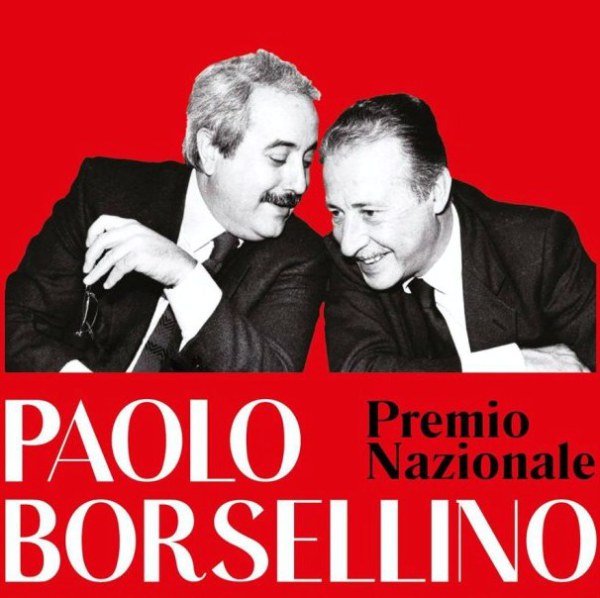Con il passare degli anni, mi sono sempre più raffigurato nella mia immaginazione la metafora della mia città vista come una nave, un veliero di media stazza, con le vele sorrette da tre alberi, il primo rappresentato dall’aspetto sociale, il secondo da quello economico e il terzo da quello culturale. Per comprendere lo stato della nave e la sua capacità di sfidare le onde e procedere verso il proprio destino, la sua meta, corrispondente con la sua rotta, è necessario considerare lo stato dei tre alberi e delle vele da essi sorrette. L’esame dello stato di salute e di conservazione degli alberi e delle vele può riguardare tanto la navigazione già effettuata (il passato), che quella attuale (il presente). Il tragitto, cioè il legame tra il passato e il presente, può dare preziose informazioni e consentire previsioni riguardo alla navigazione futura e alla probabilità che la nave scampi ad un fatale naufragio, pericolo che incombe da sempre su ogni imbarcazione, come bene apprese Ulisse nei dieci anni che trascorse cercando di tornare nella sua Itaca con il suo equipaggio.
Con il passare degli anni, mi sono sempre più raffigurato nella mia immaginazione la metafora della mia città vista come una nave, un veliero di media stazza, con le vele sorrette da tre alberi, il primo rappresentato dall’aspetto sociale, il secondo da quello economico e il terzo da quello culturale. Per comprendere lo stato della nave e la sua capacità di sfidare le onde e procedere verso il proprio destino, la sua meta, corrispondente con la sua rotta, è necessario considerare lo stato dei tre alberi e delle vele da essi sorrette. L’esame dello stato di salute e di conservazione degli alberi e delle vele può riguardare tanto la navigazione già effettuata (il passato), che quella attuale (il presente). Il tragitto, cioè il legame tra il passato e il presente, può dare preziose informazioni e consentire previsioni riguardo alla navigazione futura e alla probabilità che la nave scampi ad un fatale naufragio, pericolo che incombe da sempre su ogni imbarcazione, come bene apprese Ulisse nei dieci anni che trascorse cercando di tornare nella sua Itaca con il suo equipaggio.
La mia città, Teramo, sono secoli che naviga e solca le onde e spera di poter continuare a farlo ancora per secoli, scampando al naufragio, di cui però io ogni giorno che passa temo l’eventualità, sembrandomi che lo stato attuale degli alberi e delle vele sia pessimo, rendendo quasi inevitabile la triste conclusione di finire in fondo al mare.
Non sono salito a bordo di questa nave da poco tempo e molte miglia marine ho navigato sopra il mio veliero. Per la verità non solo nemmeno salito a bordo, perché in quelle imbarcazioni che sono le città non si sale a bordo, ma ci si nasce e si prende coscienza di essere naviganti con qualche anno di ritardo rispetto alla nascita. A poco a poco si capisce che si sta su una nave, con un equipaggio e altri passeggeri, con gli ufficiali e un comandante che cerca si seguire la rotta tracciata, non sempre da lui, ma spesso assegnata da altrui volontà o dal destino, o da una vocazione di cui non si coglie razionalmente l’origine.
Nella stiva della nave, come in tutte le imbarcazioni che mi figuro come città in cui si vive da naviganti, sono conservati i registri di bordo del passato, meno che quello del presente, che sta nella cabina del pilota e le ultime pagine sono sul posto di comando, dove c’è il timone, che il timoniere regge seguendo i comandi e le indicazioni del comandante. Fin da quando ho capito, ancora giovane, che ero assai attratto dalla conoscenza dei tratti di mare già solcati dal mio veliero, ho avuto la irrinunciabile tentazione di recarmi nella stiva per consultare i più vecchi dei registri di bordo, per capire per quali mari avesse navigato la mia nave-città. Mi è stato possibile constatare anche che pochissimi miei compagni di viaggio avevano la mia stessa curiosità e che la maggior parte di coloro che stavano con me sulla nave erano interessati solo alla navigazione presente ed erano assai poco attratti perfino dalla navigazione futura. Voglio dire che la maggior parte dei miei compagni di viaggio si disinteressavano del tutto o quasi della rotta, fidandosi completamente del comandante, al quale delegavano ogni scelta. Per la verità, si disinteressavano anche delle condizioni degli alberi e delle vele, non ponendosi mai dubbi sulla loro tenuta e non preoccupandosi mai della loro manutenzione.
Coloro che navigano insieme con me su questa nave che si chiama Teramo non si interessano molto della storia della loro città-nave, per questo dico a me stesso che i teramani sono gente senza memoria, che degli approdi passati poco si cura avendo per essi assai poca curiosità. Io, invece, ho avuto per essi sempre molto interesse le mia curiosità al riguardo è stata vorace. Ho ricercato, ho voluto sapere, ho amato informarmi, per sapere da dove venivamo, sapendo che il saperlo mi avrebbe aiutato a capire dove stavamo andando.
Sono stato in grado, grazie alle mie ricerche, non solo di sapere in quali porti eravamo arrivati, ma anche in quali condizioni erano i nostri alberi e le nostre vele, la nostra chiglia, quando il veliero era approdato in qualche porto, e in quali condizioni era l’ancora alla quale ci si era affidati gettandola in quel porto, pronti a levarla al momento di ripartire per riprendere la navigazione.
Io so, in grandi linee, e con maggiori certezze a mano a mano che ci si avvicina al tempo presente, quali siano state nei determinati tempi scanditi dal pendolo della storia, le condizioni del nostro vivere insieme (il piano sociale), delle nostre risorse (il piano economico), e del nostro sapere comune (il piano culturale). Io so in quali epoche questi tre piani sono stati floridi e in quali esangui e deperiti, in quali tratti di mare abbiamo navigato tra i perigli e in quali abbiamo navigato nella bonaccia, in quali periodi l’imbarcazione ha avuto buoni comandanti e in quali ne ha avuti di pessimi, in quali il timone è stato retto con mani sicure da esperti timonieri, e in quali invece esso è sfuggito al controllo delle mani insicure di timonieri con poca esperienza. Il confronto con le condizioni del passato mi rende capace di valutare quelle del presente e di poter dire se corriamo pericolo di naufragio o no. Io so quando il nostro veliero ha corso il rischio di naufragio e solo la fortuna ha fatto scampare il pericolo, e quando, al contrario, quel pericolo non lo si è corso e la navigazione è stata sicura e a gonfie vele. Cercherò di spiegare il come e il quando e il quanto di questa navigazione, raffrontandola alla presente, annunciando però, come ho già fatto, che oggi il rischio di naufragio mi sembra non più a lungo scongiurabile, anzi quasi certo.
ELSO SIMONE SERPENTINI