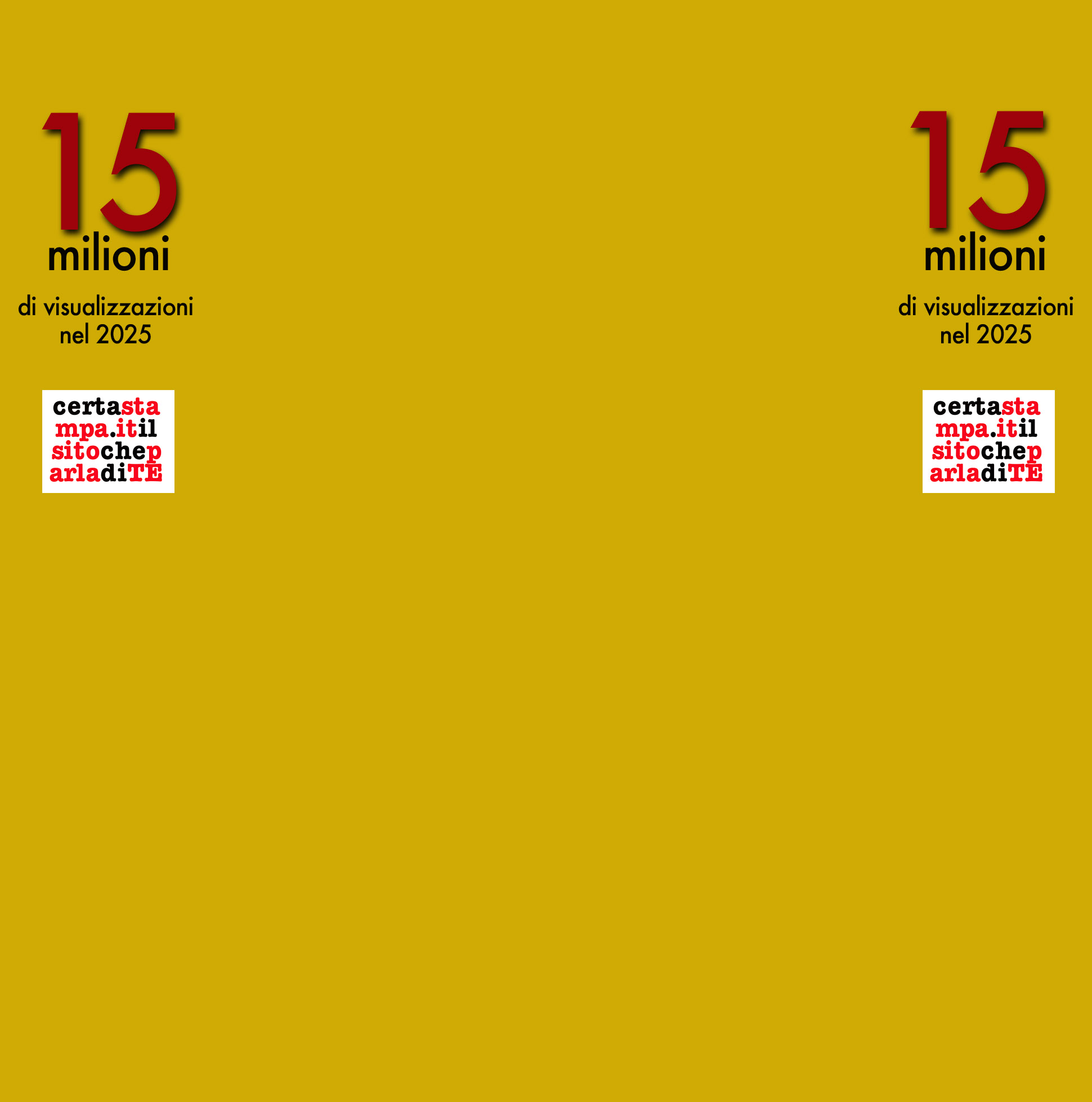Non mi è piaciuto “Io capitano”. È molto probabile che vinca l’Oscar, ma non mi è piaciuto. Lo dico anche a costo di essere considerato dissonante per partito preso, dopo la mia recensione sul film della Cortellesi, “C’è ancora domani”, che ha raccolto oltre 300 mila letture, ma tra le quali non sono mancate accuse di forzato bastiancontrarismo.
Non mi è piaciuto “Io capitano”. È molto probabile che vinca l’Oscar, ma non mi è piaciuto. Lo dico anche a costo di essere considerato dissonante per partito preso, dopo la mia recensione sul film della Cortellesi, “C’è ancora domani”, che ha raccolto oltre 300 mila letture, ma tra le quali non sono mancate accuse di forzato bastiancontrarismo.
Non è così.
La verità è che, da tempo, non riesco più a trovare un film italiano che mi “riempia” di emozioni, che mi regali quelle due ore di nutrimento per gli occhi, la mente e l’anima, che pretendo dal cinema.
E comincio anche a pensare, vi confesso, che forse la generale esaltazione che sento avvolgere questa o quella pellicola, sia figlia in realtà di una diffusa ignoranza.
Nel senso che ci si lancia in sperticate manifestazioni di consenso di un film, perché non si ha alcuna percezione del già proiettato.
È vero: ogni epoca ha i suoi riferimenti culturali, e come per i romanzi, anche i film hanno una loro stagionalità. Ma prima di esaltarsi per un qualcosa di nuovo, bisognerebbe conoscere quanto c’è di “vecchio”, perché fin troppe volte quel “vecchio” è stato così migliore del nuovo dal renderlo banale.
Tutto questo preambolo, per dire che in “Io capitano” non ho visto niente di nuovo, di emozionante.
Vero è che Garrone mi piace poco, e che per arrivare alla fine del suo “Il racconto dei racconti” ho dovuto spingermi oltre le soglie della sopportazione, così come per il suo “Pinocchio” con Benigni, una vera mattonata sulla pazienza, ma qui il discorso è diverso.
“Io capitano” non è noioso, ma è molto peggio: è scontato, prevedibile, banale, quasi didascalico nel racconto di una vicenda che è tanto vera, da sembrare falsa.
Questa storia di due ragazzi senegalesi che, dal loro villaggio, decidono di partire per arrivare in Europa, in Italia, è esattamente come te la immagini.
Con i drammi quotidiani di un’umanita devastata dalla povertà, nella quale la violenza del più forte sul più debole si declina in ogni possibile sfaccettatura: dai poliziotti / predoni in Libia, alle guardie di frontiera corrotte in Mali, agli scafisti senza scrupoli, alle guardia costiera maltese che non risponde alle chiamate.
Tutto già visto nei tg.
Tutto già letto in cronaca.
Un film che sembra un documentario, anzi: una puntata di report, ma allungata, non giornalistica e superficiale, nella quale - paraculescamente - Garrone sceglie la “lingua originale”, solo per farci scoprire alla fine che non ha nessun valore narrativo.
Pensavo che la scelta del wolof, del francese e dell’inglese fosse necessaria, perché avrebbe fatto da contrasto all’italiano degli “europei”, ma non è così, perché gli italiani non si vedranno mai, se non sotto forma di elicottero e l’unica parola “a contrasto” è proprio l’ “io capitano” che Seydou griderà a quell’elicottero.
Se tutti nel film fossero stati doppiati, non sarebbe cambiato nulla, se non l’effetto di quella battuta finale, ma ci saremmo risparmiati il fastidio (per me insopportabile) di dover guardare un film leggendo i sottotitoli, che distraggono dalle immagini.
Ecco, le immagini. La fotografia di Paolo Carnera è superba. Anche se evoca, e credo che siano quasi citazioni le sue, certi campi larghi de “La mia Africa” e certi controluce sahariani di “Lawrence d’Arabia”, tutto il viaggio nel deserto è un vero dipinto, che - a differenza del resto del film - non cerca il gioco facile, scivolando magari sugli stereotipi, ma continua a regalarci suggestioni e orizzonti che, contrastando col dramma dei protagonisti, ridefinisce gli spazi dell’uomo e quelli della Natura. Nello svolazzare onirico della donna abbandonata tra le dune, ho rivisto il volteggiare angoscioso dei dissenatori di Harry Potter, ma ci sta.
La fotografia, per quanto non inedita nelle scelte, è l’unica cosa salvabile, con l’interpretazione di Seydou, del lungo documentario prevedibile di Garrone. Raccontare l’emigrazione, il viaggio terribile di chi lascia il proprio mondo per cercare fortuna in un altro, non è e non può essere solo la cronaca del viaggio tremendo. Garrone gioca tutte le sue carte sul senso di colpa del “Primo Mondo”, che guarda al “Terzo” con la consapevole certezza di aver preso tanto e dato poco. Un film che, se in Italia può assumere una valenza anche politica, entrando a gamba tesa nel dibattito sulla gestione dei migranti, in America assume una valenza totalmente diversa, richiamando gli “yankee” al confronto con la ferita aperta della schiavitù.
Per questo, è un film che avrà grandissime possibilità di vincere l’Oscar.
Ma il cinema è altra cosa.
E non riesco a trovare “cinema”, nel senso più puro, del termine, in “Io Capitano”, se nella memoria conservo, a proposito di emigrazione, il tratteggio conflittuale delle vite di “Rocco e i suoi fratelli”. E se negli occhi di Seydou, che guardano il mare di notte, c’è il racconto del dolore di uno spicchio d’Africa, in quelli del biondo cameriere Manfredi, alla fine di “Pane e cioccolata” c’è il racconto di dolore di generazioni di italiani, da sempre “fratelli poveri” dell’Europa ricca.
E non vado oltre, perché basterebbero tre scene di “Lamerica” di Gianni Amelia a rendere cinematograficamente inconsistente il peschereccio di Garrone.
Quella della questione africana è una tragedia che meritava di essere raccontata meglio di un film noioso, lungo e prevedibile. Che probabilmente vincerà l’Oscar, consentendo ai signori dell’Academy di tornarsene a casa, dopo la cerimonia, con l’anima più leggera e all’Italia di vantarsi di una nuova statuetta, mentre dalle spiagge della Libia, partono ogni notte altri Seydou…
IL CRITICONE