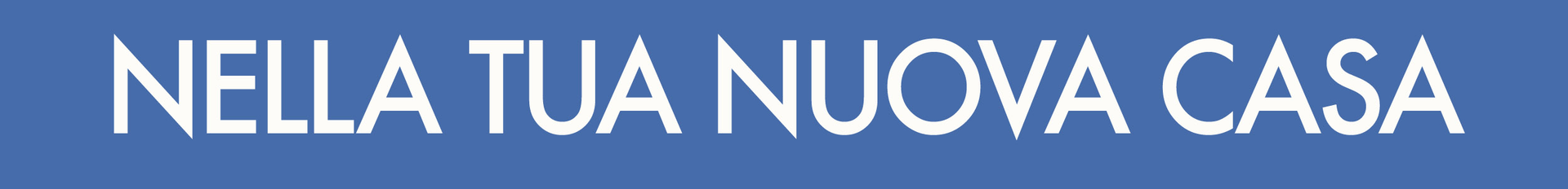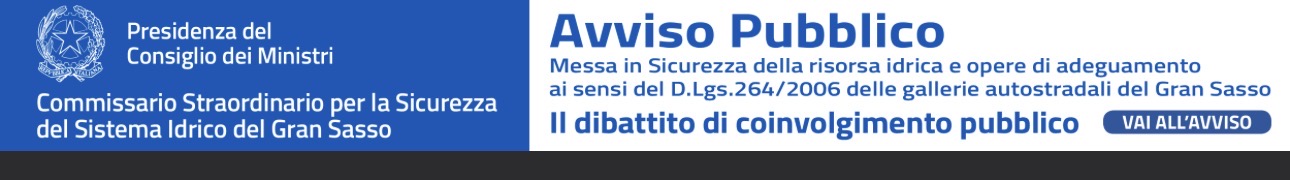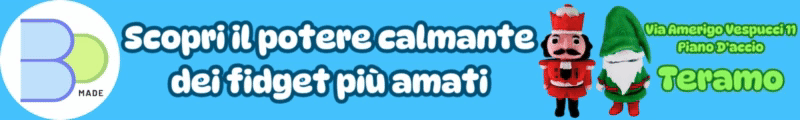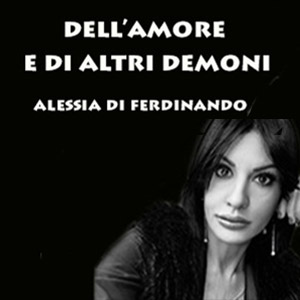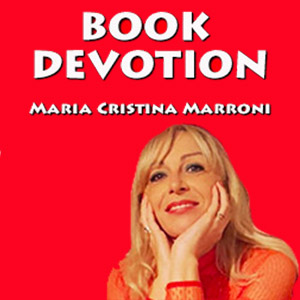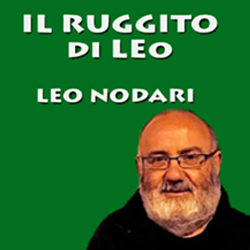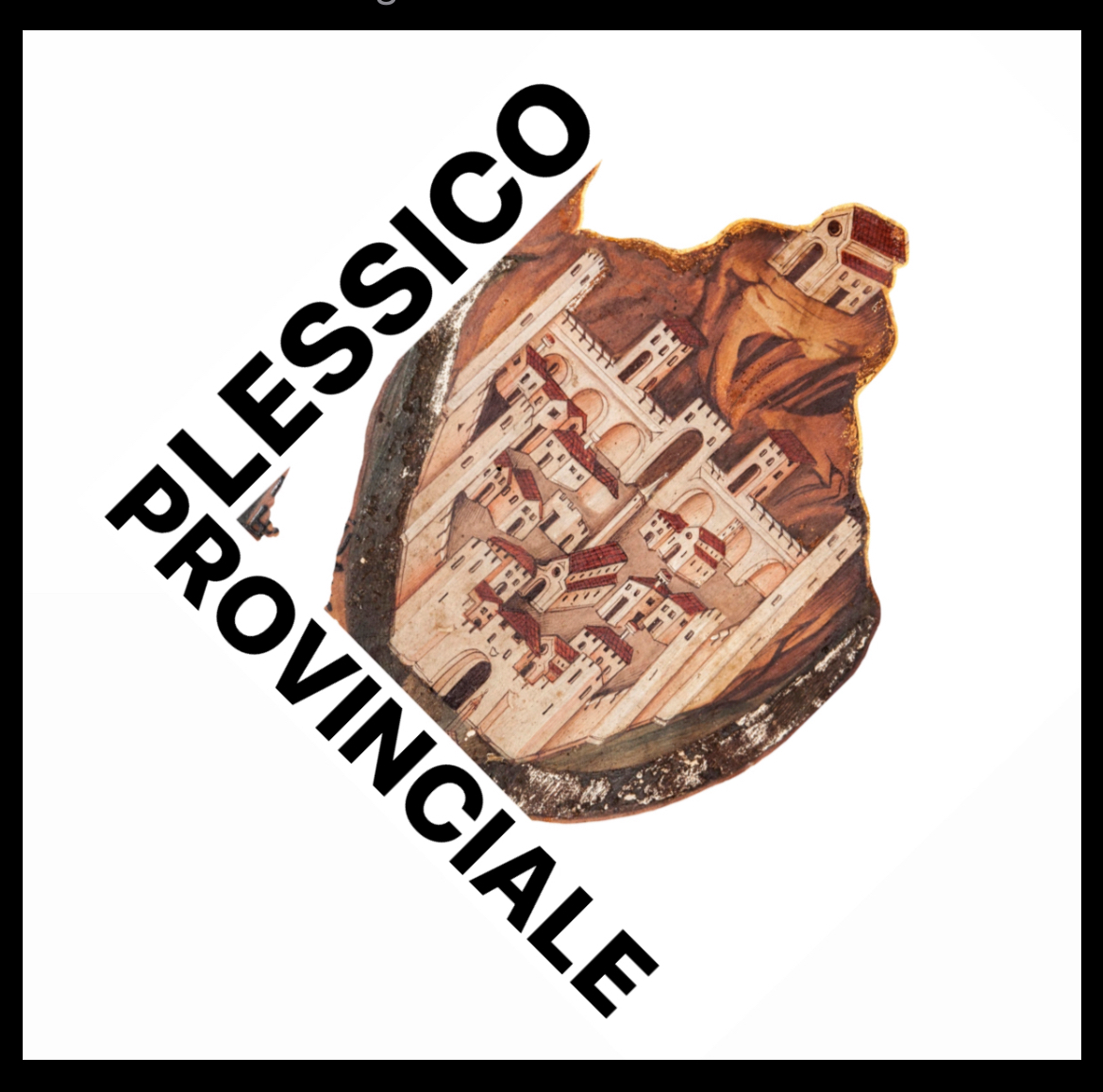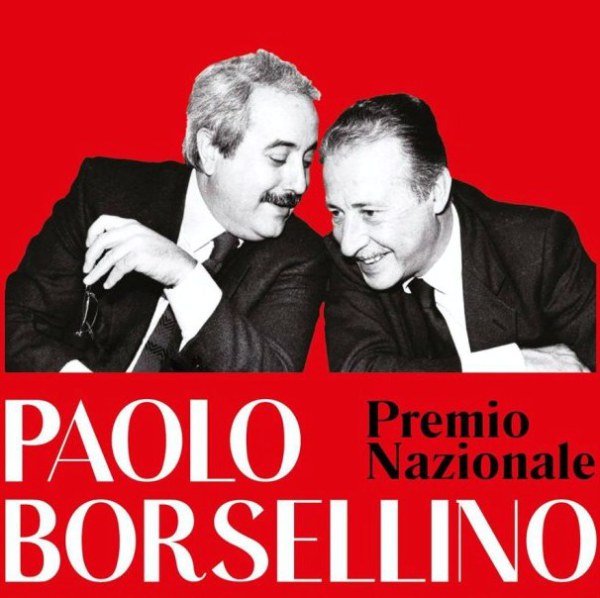Non staremo qui a citare frasi straconosciute, per sottolineare quale sia la differenze tra coincidenze, indizi e prove, perché ormai lo sapete fin troppo bene che un inchiesta che ambisca a trovare una soluzione ad un giallo, si nutre di prove. Solo di prove. Benvengano coincidenze e indizi, ma sono le prove quelle che segnano la strada da seguire. Ecco perché, in questa nostra prima puntata dell’inchiesta sulla paternità musicale di Arvì, la splendida canzone popolare abruzzese che Enrico Melozzi non porta alla Notte dei Serpenti, proprio a causa di una “contesa”, comincia con una prova. Questa:

È uno spartito, antico, della canzone e reca, con assoluta chiarezza, come si usa fare, i nomi degli autori: “Misantone - Giannascoli”. Ora, se sul fatto che Antonio Misantone, medico condotto a Montefino e poeta, sia l’autore del testo non ci sono dubbi, quel riferimento a Giannascoli apre uno scenario nuovo, visto che “ufficialmente” Arvì è di Misantone - Vetuschi, ovvero dell’indimenticato direttore della Corale Verdi di Teramo.
E allora chi è Gianni Giannascoli?
«Un eclettico musicista di Castilenti, che fu collaboratore di Misantone, con il quale scriveva molte canzoni e che, come mi hanno raccontato i figli, fu l’autore della musica di Arvì» racconta Antonio Di Donato, cultore di storia locale e, di fatto, primo tassello della vicenda, visto che è stato proprio lui ad inviare ad Enrico Melozzi quella “segnalazione di dubbia paternità musicale”, che tiene Arvì lontana dalla Notte dei Serpenti, almeno fino a quando non sarà tutto chiarito.
Quando l’hanno composta, o meglio: quando firmano quello spartito, Misantone e Giannascoli non sono nella condizioni di poter incidere un disco con “Arvì”, perché le sale d’incisione erano solo a Milano e Roma, ma neanche di andare ad Ancona per depositarla alla Siae, perché comunque sarebbe stato necessario andare di persona e spendere qualche soldo di quelli che, in quella fase storica, non erano mai troppi.
Infatti, per quanto talentuoso e più volte premiato per le sue composizioni, Giannascoli con la musica non poteva vivere, così seguì l’esempio di tanti altri figli d’Abruzzo e prese la strada dell’emigrazione:
«Andò a vivere in Germania, dove aprì una sartoria con la moglie; a Castilenti tornarono solo molto tempo dopo, negli Anni ’80, riportando in Italia una traccia familiare di quel talento musicale, visto che la figlia insegna al conservatorio di Taranto e il figlio è psicologo a Chieti e per hobby musicista eclettico - continua Di Donato - ma fu proprio nel tornare in Italia, che Giannascoli scoprì che Arvì era stata depositata con “Misantone - Vetuschi” e la cosa fu sempre per lui motivo di grande dolore».
Un dolore che, ed anche questo dettaglio viene interpretato come significativo, Giannascoli viveva intimamente: «Della storia di Arvì. si lamentava spesso all’interno del suo mondo familiare, coi figli, non in pubblico e raramente con conoscenti, era per lui un dolore profondo, vero - continua Di Donato - e questa mi sembra un’ulteriore dimostrazione di quale sia stata la storia di quella canzone…»
Può bastare una “certezza familiare” a definire il caso?
Teoricamente no, ma siccome parliamo di prova, dobbiamo tornare a quello spartito, che è certo una prova documentale.
Per oggi, fermiamoci qui, anche perché nelle prossime puntate scopriremo che se è vero che “scripta manent”, anche “verba volant” hanno il loro peso, specie se volano su uno spartito.