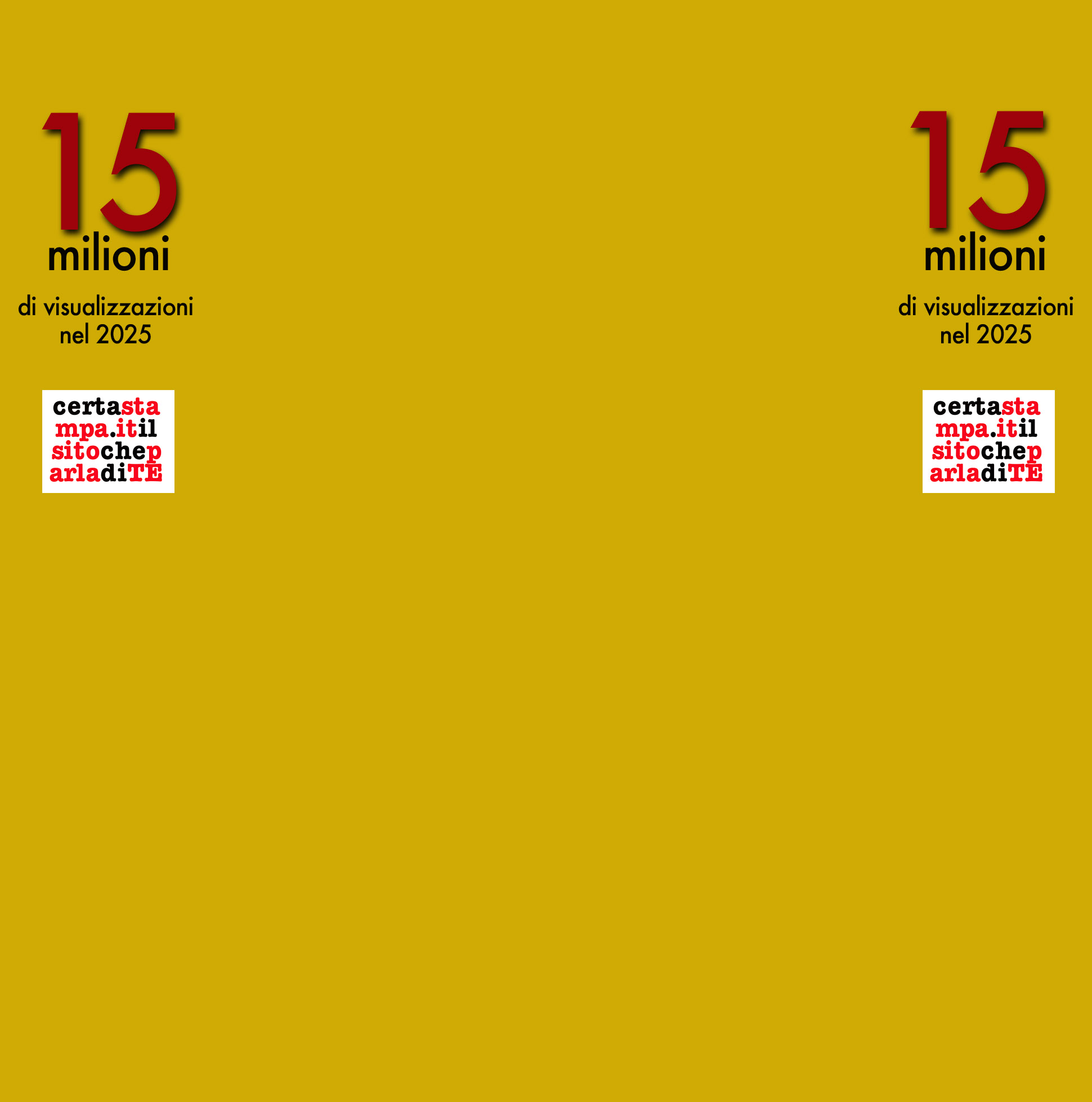La tesi della “riqualificazione della condotta” non regge di fronte alla brutalità dei fatti. Secondo l’accusa, parlare di attenuazione dopo un’aggressione culminata in 92 fendenti è una contraddizione evidente, tanto più che lo stesso imputato ha riferito di essersi fermato solo perché fisicamente incapace di continuare. Su queste basi, la Procura generale ha chiesto la conferma integrale della decisione di primo grado. La Corte d’Assise d’Appello ha accolto la richiesta, lasciando invariata la condanna a 14 anni di reclusione inflitta dal Tribunale di Teramo a Francesco Di Rocco, 49 anni, ritenuto responsabile dell’uccisione del padre Mario, 83 anni, ex capostazione, avvenuta nel 2023. Nessun accoglimento, dunque, per l’istanza difensiva che mirava a riaprire l’istruttoria, sia per una diversa ricostruzione dell’episodio sia per disporre una nuova perizia psichiatrica. Per l’accusa, il quadro probatorio è già completo: la causa del decesso è stata individuata senza margini di dubbio nell’elevato numero di ferite inferte, mentre eventuali patologie pregresse della vittima sono state giudicate del tutto irrilevanti. Allo stesso modo, non sono emersi elementi che possano avvalorare l’ipotesi di una condotta provocatoria tale da giustificare l’azione dell’imputato. La pena, secondo questa lettura, rispecchia pienamente la gravità del fatto. Quanto alle attenuanti generiche, la Procura ha ricordato come fossero già state riconosciute in primo grado con valore prevalente, proprio alla luce del contesto familiare segnato da anni di soprusi e violenze domestiche cui l’imputato avrebbe assistito sin dall’infanzia. Un riconoscimento che, tuttavia, non poteva spingersi oltre. Nelle motivazioni della sentenza di primo grado i giudici avevano descritto un uomo che si sentiva prigioniero di una quotidianità oppressiva, aggravata dopo la morte della madre. L’ennesimo scontro con il padre, culminato in minacce di estromissione da casa e di interruzione delle utenze, avrebbe innescato una reazione incontrollata, maturata su un rancore profondo e mai elaborato. Da qui il riconoscimento dello stato d’ira, inteso come risposta a una lunga serie di comportamenti percepiti come ingiusti. La difesa, pur prendendo atto dell’esito del giudizio, ha sottolineato come restino aspetti non sufficientemente approfonditi, auspicando che nelle motivazioni la Corte possa colmare quelle che vengono ritenute lacune dell’impianto originario. In particolare, è stata ribadita la necessità di analizzare più a fondo le dinamiche relazionali e lo stato psicologico complessivo che avrebbe preceduto l’evento.
La tesi della “riqualificazione della condotta” non regge di fronte alla brutalità dei fatti. Secondo l’accusa, parlare di attenuazione dopo un’aggressione culminata in 92 fendenti è una contraddizione evidente, tanto più che lo stesso imputato ha riferito di essersi fermato solo perché fisicamente incapace di continuare. Su queste basi, la Procura generale ha chiesto la conferma integrale della decisione di primo grado. La Corte d’Assise d’Appello ha accolto la richiesta, lasciando invariata la condanna a 14 anni di reclusione inflitta dal Tribunale di Teramo a Francesco Di Rocco, 49 anni, ritenuto responsabile dell’uccisione del padre Mario, 83 anni, ex capostazione, avvenuta nel 2023. Nessun accoglimento, dunque, per l’istanza difensiva che mirava a riaprire l’istruttoria, sia per una diversa ricostruzione dell’episodio sia per disporre una nuova perizia psichiatrica. Per l’accusa, il quadro probatorio è già completo: la causa del decesso è stata individuata senza margini di dubbio nell’elevato numero di ferite inferte, mentre eventuali patologie pregresse della vittima sono state giudicate del tutto irrilevanti. Allo stesso modo, non sono emersi elementi che possano avvalorare l’ipotesi di una condotta provocatoria tale da giustificare l’azione dell’imputato. La pena, secondo questa lettura, rispecchia pienamente la gravità del fatto. Quanto alle attenuanti generiche, la Procura ha ricordato come fossero già state riconosciute in primo grado con valore prevalente, proprio alla luce del contesto familiare segnato da anni di soprusi e violenze domestiche cui l’imputato avrebbe assistito sin dall’infanzia. Un riconoscimento che, tuttavia, non poteva spingersi oltre. Nelle motivazioni della sentenza di primo grado i giudici avevano descritto un uomo che si sentiva prigioniero di una quotidianità oppressiva, aggravata dopo la morte della madre. L’ennesimo scontro con il padre, culminato in minacce di estromissione da casa e di interruzione delle utenze, avrebbe innescato una reazione incontrollata, maturata su un rancore profondo e mai elaborato. Da qui il riconoscimento dello stato d’ira, inteso come risposta a una lunga serie di comportamenti percepiti come ingiusti. La difesa, pur prendendo atto dell’esito del giudizio, ha sottolineato come restino aspetti non sufficientemente approfonditi, auspicando che nelle motivazioni la Corte possa colmare quelle che vengono ritenute lacune dell’impianto originario. In particolare, è stata ribadita la necessità di analizzare più a fondo le dinamiche relazionali e lo stato psicologico complessivo che avrebbe preceduto l’evento.