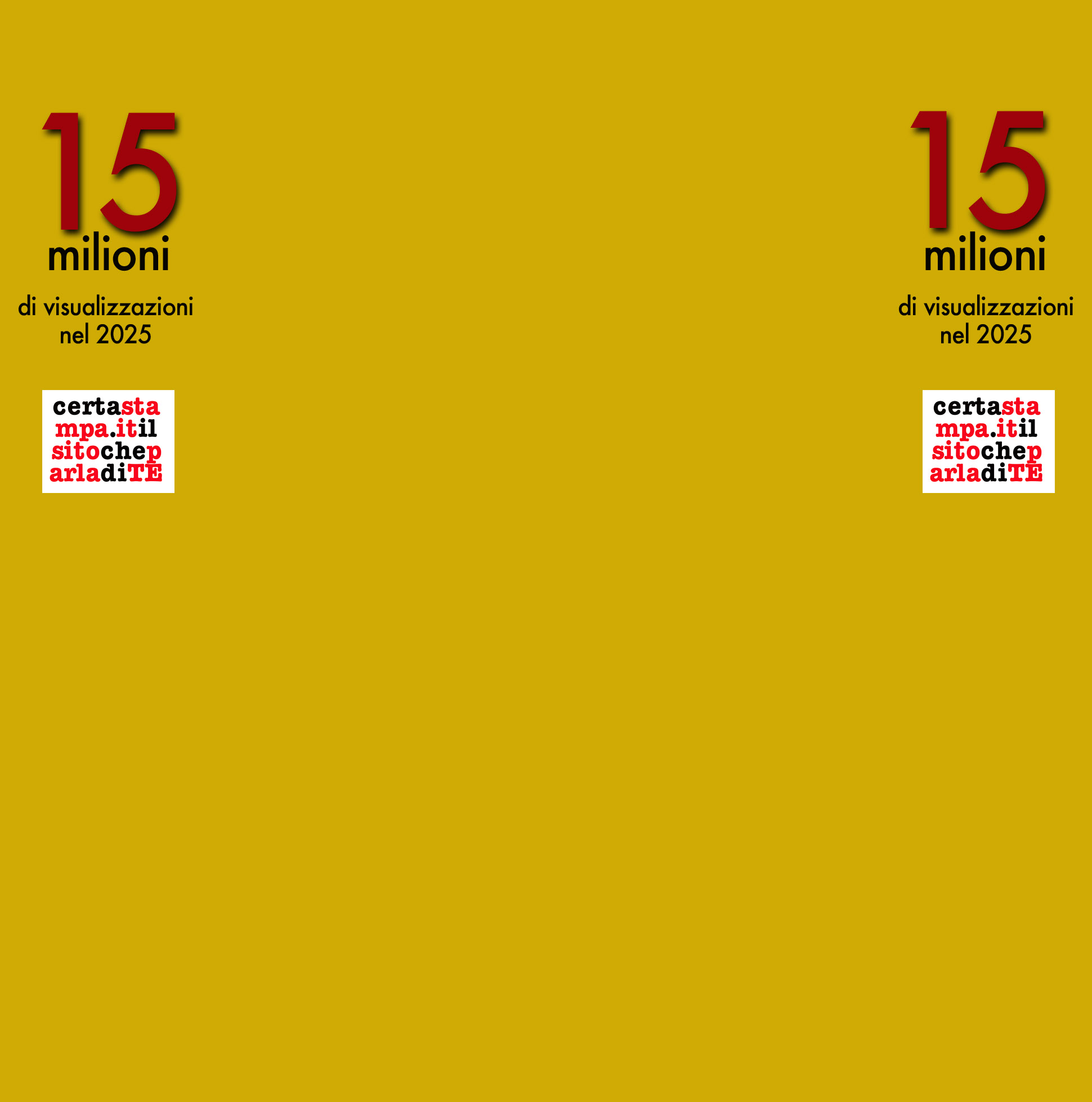C’è una voce che circola con una certa insistenza nei corridoi cittadini: il Comune starebbe valutando di destinare il Castello della Monica — già oggetto di restauri e di un dibattito senza fine sulla sua funzione — anche a sede della nascente Fondazione ACS. Un soggetto nuovo, o forse la trasformazione dell’attuale ACS (o ancora una sua articolazione), o magari solo un caso di omonimia acronima, ma che avrebbe un compito ambizioso: coordinare tutte le manifestazioni del territorio e gestire i relativi contributi pubblici. E sarebbe di diretta partecipazione comunale. È, appunto, una voce. Nulla di ufficiale. Magari un pettegolezzo. Ma le voci, soprattutto quando trovano terreno fertile, meritano attenzione: spesso raccontano più del clima amministrativo che dei fatti in sé. Il contesto è noto. Il Comune distribuisce ogni anno una quantità rilevante di contributi a eventi, associazioni, iniziative culturali etc etc . E ogni stagione di assegnazioni porta con sé il suo strascico di polemiche. Un copione che si ripete da anni, mentre la trasparenza amministrativa procede a singhiozzo (basti pensare che la sezione contributi del sito istituzionale risulta ferma ad aprile 2025). In questo quadro, l’idea — se tale è — di una Fondazione che faccia da cabina di regia può apparire seducente. Il Comune contribuirebbe alla Fondazione, e la Fondazione distribuirebbe le risorse e coordinerebbe le attività. Un livello intermedio che alleggerirebbe l’ente pubblico dal peso diretto delle scelte, spostandole su un organismo formalmente autonomo. Autonomia piena, si direbbe. O quantomeno presunta, visto che è intuibile quanto la politica di un ente controllante e sovvenzionante potrebbe poi incidere sulle scelte. Il modello non è nuovo: molte amministrazioni hanno esternalizzato funzioni culturali e promozionali a fondazioni partecipate. I vantaggi sono evidenti — flessibilità gestionale, rapidità operativa, minore esposizione politica — ma altrettanto evidenti sono i rischi: minore controllo, concentrazione di potere in pochi soggetti, facilità di spesa. Tutto dipende da statuto, governance, criteri di selezione, obblighi di trasparenza. E poi c’è il luogo. Il Castello della Monica non è un edificio qualsiasi: è simbolo identitario, patrimonio storico, spazio pubblico per definizione. Destinarlo a sede di una struttura gestionale — ancorché culturale — significherebbe imprimergli una funzione precisa e, in qualche misura, esclusiva. Da contenitore civico a quartier generale di un ente. Una scelta che, se confermata, meriterebbe un dibattito aperto, non sussurrato. Per ora, appunto, siamo nel campo delle voci. Ma proprio perché si tratta di una voce, il Comune farebbe bene a chiarire: esiste davvero un progetto di Fondazione al CAstello? Quale rapporto con l’ACS attuale? Quali competenze, quali risorse, quali regole di assegnazione dei contributi? E soprattutto: quale destinazione per il Castello? La trasparenza, in questi casi, non è un adempimento ma un antidoto. Perché quando le scelte su cultura e denaro pubblico si intrecciano, le voci riempiono inevitabilmente i vuoti di informazione. E il castello, da simbolo cittadino, rischia di diventare metafora: marcondirondirondello, il girotondo delle competenze, delle deleghe, delle responsabilità che passano di mano, finché non si capisce più chi decide davvero. Se è solo un pettegolezzo, smentirlo è semplice. Se è un’idea, spiegarla è doveroso. In entrambi i casi, il silenzio è la scelta peggiore.