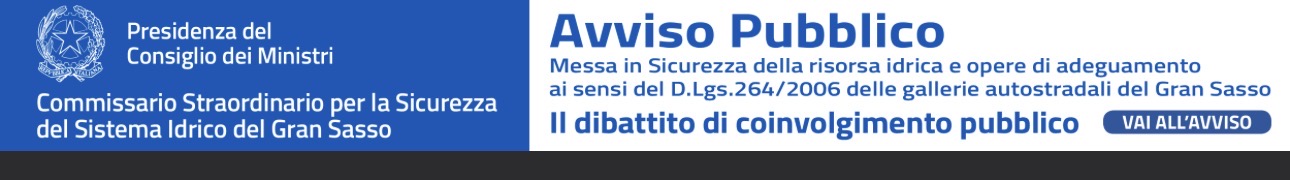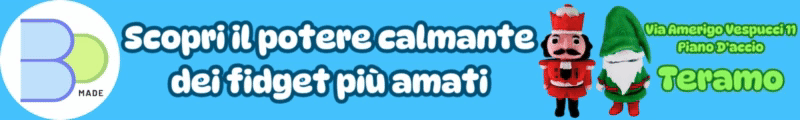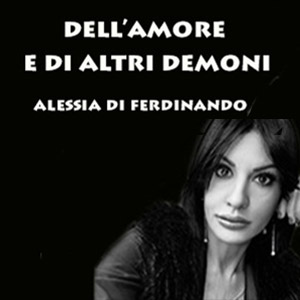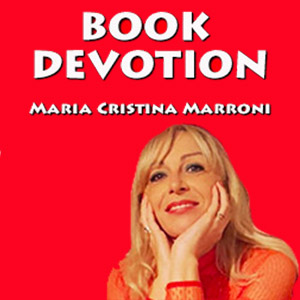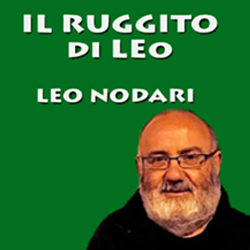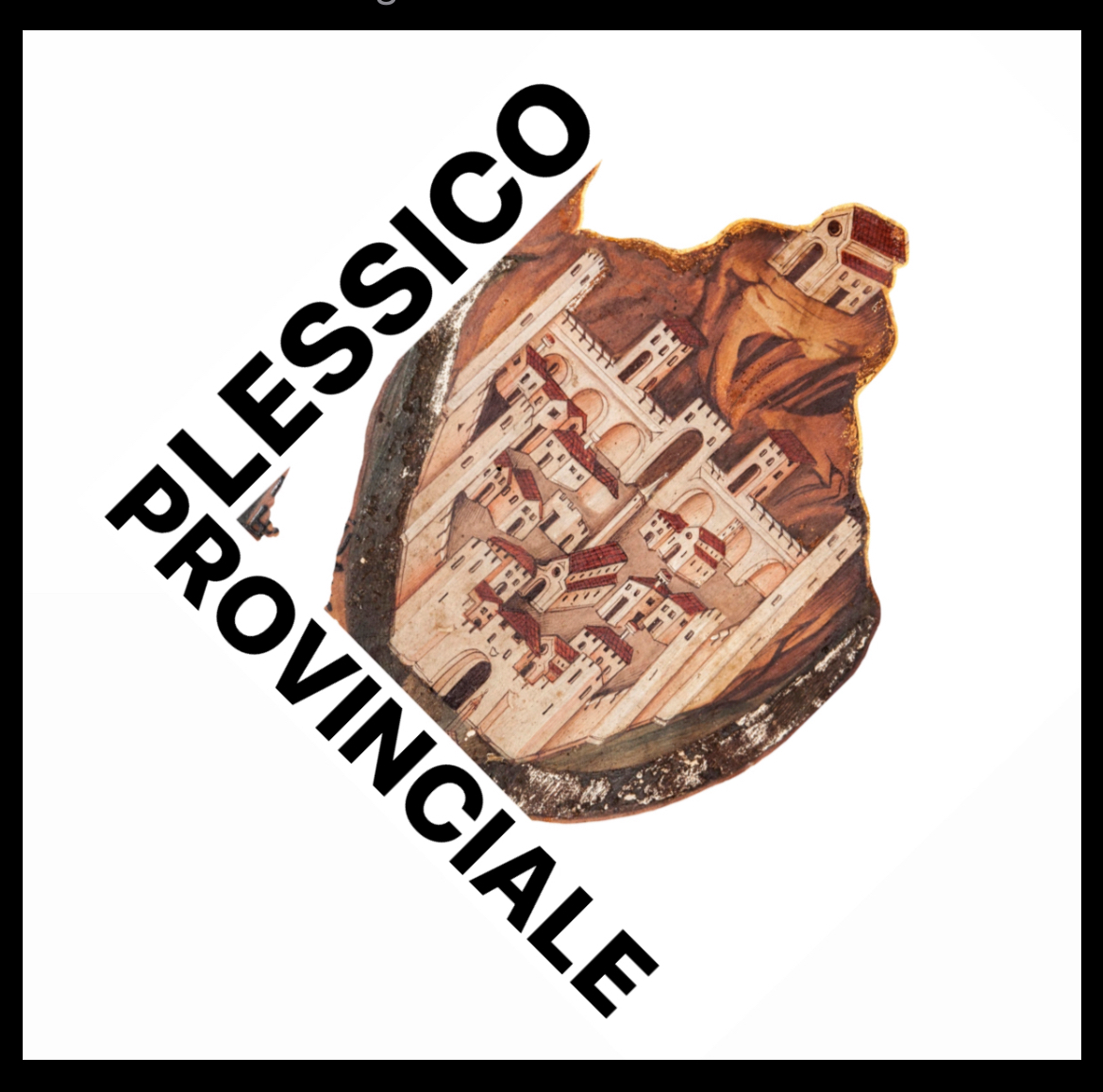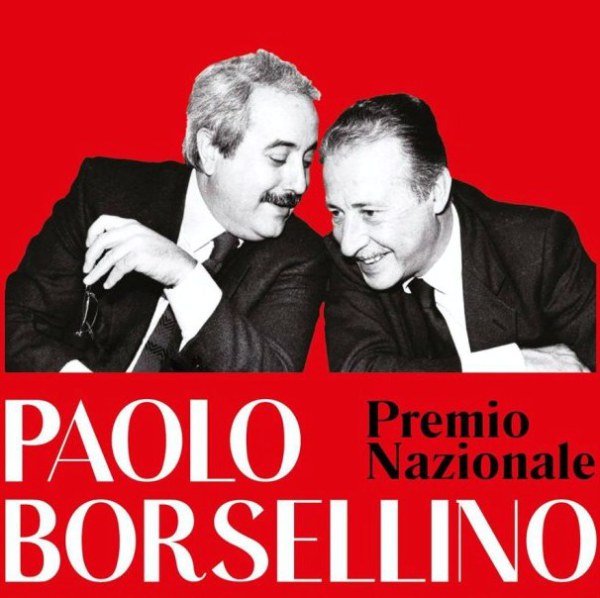🚸Il caso dei tre bambini allontanati dalla casa nel bosco di Palmoli, in provincia di Chieti, riporta al centro del dibattito pubblico un tema delicatissimo: fino a che punto lo Stato può – e deve – intervenire sulle scelte di vita dei genitori? E, soprattutto, la sofferenza enorme dell’allontanamento è davvero inevitabile per tutelare i minori, o esistono alternative meno traumatiche?
Il Tribunale per i minorenni dell’Aquila ha disposto il collocamento dei tre figli della coppia anglo-australiana in una comunità educativa, con la madre che li accompagna per un periodo di osservazione, sospendendo la responsabilità genitoriale e nominando un tutore provvisorio. 
Le condizioni di vita – rudere fatiscente, assenza di utenze, precedenti problemi di sicurezza alimentare (intossicazione da funghi), istruzione non convenzionale – sono state ritenute idonee ad integrare un quadro di “grave pregiudizio” per i minori. 
Questa vicenda, però, non può essere letta come uno scontro tra “stile di vita alternativo” e “Stato oppressivo”: il diritto offre parametri precisi, e impone un bilanciamento serrato tra libertà familiare e interesse superiore del minore.
📌1. Il quadro normativo: tra libertà familiare e dovere di protezione.
La Costituzione riconosce e protegge la famiglia, fondando su di essa l’educazione dei figli (artt. 29, 30, 31), ma affida alla Repubblica il compito di proteggere l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.
A livello sovranazionale, la Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia stabilisce che il minore non deve essere separato dai genitori contro la loro volontà, se non quando ciò sia necessario nel suo “superiore interesse” (artt. 8-9). 
La separazione, quindi, è ammessa, ma come misura eccezionale, rigorosamente motivata.
In parallelo, l’art. 8 CEDU tutela il diritto al rispetto della vita familiare: la Corte EDU ha più volte ribadito che l’allontanamento di un minore deve essere giustificato da motivi particolarmente forti e accompagnato da un progetto volto, ove possibile, al ricongiungimento.
Il nuovo art. 403 c.c. (riformato nel 2022) consente l’intervento urgente dell’autorità pubblica quando il minore:
• si trovi in stato di abbandono materiale o morale, oppure
• sia esposto, nell’ambiente familiare, a grave pregiudizio o grave pericolo per la sua incolumità psico-fisica, prevedendo l’allontanamento in comunità e un rapido controllo giudiziale, con ascolto del minore e garanzie difensive. 
📌2. È ancora attuale la misura dell’allontanamento?
Alla domanda se la misura sia “attuale”, la risposta del diritto è duplice:
1. Sì, è attuale e necessaria in presenza di un grave e attuale pericolo per il minore (abusi, maltrattamenti, grave trascuratezza, condizioni igienico-sanitarie che mettano a rischio vita o salute, isolamento totale da cure e istruzione).
2. No, non è uno strumento neutro: la separazione determina un danno psicologico potenzialmente gravissimo, che il giudice deve valutare e ridurre al minimo indispensabile.
Ciò significa che non basta ritenere “discutibile” lo stile di vita dei genitori: occorre una prova concreta che la permanenza in quel contesto comporti un rischio serio e non gestibile con strumenti meno drastici.
📌3. La sofferenza da allontanamento: danno necessario?
Separare un bambino dal proprio ambiente di vita e dalle figure di attaccamento produce un trauma relazionale:
• rottura delle routine affettive,
• senso di abbandono,
• paura e sfiducia negli adulti e nelle istituzioni.
Il diritto non nega questa sofferenza: la assume come danno certo, da mettere sul piatto della bilancia rispetto al danno, potenziale o attuale, connesso alla permanenza nel nucleo familiare.
La giurisprudenza ha sottolineato che provvedimenti ablativi della responsabilità genitoriale e drastici trasferimenti del minore devono tener conto del rischio di un trauma “anche irreparabile” derivante dal brusco distacco dal genitore con cui il bambino ha sempre vissuto. 
In altri termini: il dolore della separazione non è mai “irrilevante”, nemmeno quando viene adottata una soluzione che dovrebbe tutelare il minore. Va sempre dimostrato che:
• senza allontanamento, la salute fisica o psichica del minore sarebbe esposta a un pericolo più grave;
• è in atto un progetto concreto per contenere il trauma e favorire, ove possibile, il ritorno in famiglia (supporti terapeutici, mediazione, accompagnamenti graduali).
📌4. È possibile proteggere i minori senza allontanarli? Strade alternative
La domanda cruciale è: si poteva – o si può – fare altro, prima di spezzare l’unità familiare?
Il diritto, se interpretato in modo evolutivo, offre una gamma di strumenti che andrebbero utilizzati in modo graduale e proporzionato, prima di arrivare alla separazione fisica:
📎A.Progetti di supporto intensivo “in situ”
• Educatori domiciliari che affianchino quotidianamente i genitori per igiene, sicurezza domestica, organizzazione degli spazi, gestione del cibo.
• Patti di corresponsabilità tra famiglia, servizi sociali e scuola, con obiettivi chiari (istruzione, controlli pediatri, vaccinazioni, ecc.) e verifiche periodiche.
• Interventi strutturali minimi co-finanziati da enti locali o terzo settore (bagno funzionale, punto acqua sicuro, sistemi di riscaldamento non pericolosi), quando la criticità è principalmente materiale e non affettiva.
📎B. Strutture miste genitore-figlio
Invece di collocare i bambini da soli in comunità, si possono prevedere soluzioni di accoglienza familiare in cui madre/padre e figli restano insieme (case famiglia genitore-bambino, villaggi educativi, comunità di tipo familiare), lavorando contemporaneamente sul rafforzamento delle competenze genitoriali.
Questa logica – già sperimentata per madri con bambini piccoli e per situazioni di violenza domestica – dovrebbe essere la regola anche nei casi di conflitto educativo e di marginalità abitativa, limitando al minimo i periodi di separazione fisica.
📎C. Mediazione educativa e culturale
Quando la frattura nasce da uno scontro di visioni (es. scuola tradizionale vs unschooling, vita urbana vs vita “selvatica”), è utile attivare:
• mediatori familiari e culturali capaci di tradurre il linguaggio dei genitori in termini giuridicamente comprensibili e, viceversa, di spiegare i vincoli normativi (obbligo di istruzione, vaccinazioni, registrazioni anagrafiche, ecc.);
• percorsi di formazione genitoriale su diritti e bisogni dei bambini, con particolare cura per salute, rischio alimentare, pericoli ambientali.
📎D.Progetti di “educazione in natura” regolata
Il caso di Palmoli mette in luce un paradosso: l’Italia conosce e finanzia esperienze di asili nel bosco e scuole in natura, dove bambini vivono quotidianamente all’aperto in contesti rurali, ma all’interno di progetti educativi formalmente riconosciuti e sorvegliati.
Questo dimostra che natura e diritto all’educazione non sono in conflitto in sé; lo diventano quando mancano: - un curricolo minimo,- figure educative qualificate, - raccordo con il sistema di istruzione, - monitoraggio sanitario.
Trasformare scelte radicali di vita in progetti formalizzati – attraverso associazioni, cooperative, convenzioni con scuole e ASL – è una strada per conciliare libertà familiari e interessi del minore.
📌5. Quale strada per il futuro?
Il caso dei bambini del bosco non è solo una storia di cronaca: è un banco di prova per il sistema di tutela minorile.
Se da un lato non è pensabile accettare che dei minori crescano senza standard minimi di sicurezza, salute, istruzione e relazioni sociali, dall’altro non è accettabile che l’unica risposta dello Stato sia, ancora una volta, l’allontanamento traumatico.
Il diritto offre già oggi alcuni principi chiave, che andrebbero tradotti in prassi:
1. Centralità dell’interesse del minore, non degli adulti.
2. Gradualità e proporzionalità: prima le misure di supporto, poi – solo se inefficaci – quelle ablative. 
3. Progetto di ricongiungimento: ogni allontanamento deve contenere, fin dall’inizio, un piano per la possibile ricostruzione della vita familiare. 
4. Ascolto autentico dei bambini e dei genitori, non solo formale, anche nei contesti mediaticamente esposti.
In questa prospettiva, la domanda da farsi non è “i genitori possono vivere nel bosco?”, ma: - e’ possibile trasformare quella scelta in un contesto compatibile con i diritti fondamentali dei bambini, senza spezzare – se non davvero inevitabile – il legame genitore-figlio?
📕La risposta, se si ha il coraggio di investire in servizi, formazione e creatività giuridica, non può che essere sì: esistono sistemi per tutelare i minori con i loro genitori, e non necessariamente contro di loro.