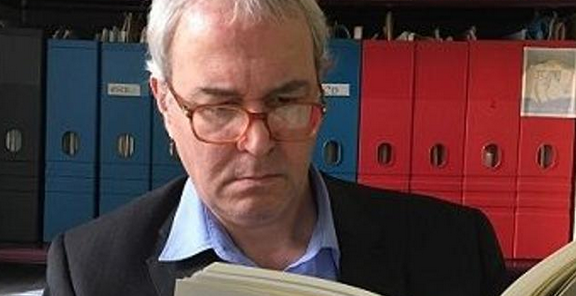 Walter Lapini è professore ordinario di Letteratura Greca presso l’Università di Genova. Fa parte del comitato scientifico delle riviste di studi classici «Prometheus» ed «Eirene». È co-direttore della collana «Pubblicazioni del D.AR.FI.CL.ET» e della collana «Margaritae» dell’Accademia Fiorentina di Papirologia e Studi sul Mondo Antico.
Walter Lapini è professore ordinario di Letteratura Greca presso l’Università di Genova. Fa parte del comitato scientifico delle riviste di studi classici «Prometheus» ed «Eirene». È co-direttore della collana «Pubblicazioni del D.AR.FI.CL.ET» e della collana «Margaritae» dell’Accademia Fiorentina di Papirologia e Studi sul Mondo Antico.
Si è occupato di storiografia greca di età classica, teatro attico, filosofia presocratica, filosofia ellenistica, epigramma, filologia filosofica, papirologia. Ha affrontato questioni di variantistica, di esegesi lessicale e lessicografica antica e moderna e di polemica storico-filosofico-letteraria, si è dedicato ricorrentemente a questioni di critica del testo e di metodologia ecdotica.
Collabora con vari quotidiani e periodici fra cui “Il Corriere della Sera”, “Il Secolo XIX” , Critica Liberale ecc…
Professore, dopo il blocco primaverile e in attesa dell’inizio del nuovo anno, che bilancio fa della didattica a distanza?
Il bilancio è buono e cattivo allo stesso tempo. Il che è logico: le situazioni estreme tirano fuori il meglio e il peggio da noi tutti. Cominciamo dalle istituzioni scolastiche: impossibile non rilevarne la tarda e zigzagante risposta. Certo, l’epidemia ci ha còlti di sorpresa. Certo, nessuno aveva un ‘piano’ per la didattica di emergenza. Ma anche quel poco che si poteva fare per organizzare, coordinare la scuola nell’insieme, non si è fatto. E non solo per incapacità o cattiva volontà, ma anche e soprattutto a causa di storture sistemiche, venute da lontano, almeno a partire dalla famosa autonomia scolastica introdotta dalla riforma Berlinguer negli ultimi anni Novanta. Una riforma rovinosa, che ha rafforzato la catena gerarchica cattiva e spazzato via quella buona, secondo il principio per cui le decisioni sarebbero tanto più efficaci e democratiche quanto più vengono prese dal basso. Ma non esiste democrazia se chi decide non ha i mezzi per farlo. Democrazia non è permettere al professori di ginnastica di sindacare sui voti di italiano, bensì creare una rete di pertinenze e di responsabilità. Servono poteri limitati e chiari, non vasti e nebulosi. Se oggi tu docente hai un problema, non sai a chi chiedere aiuto, non hai punti di riferimento. Nessuno si fa carico di nulla. Nessuno neanche sa chi è il suo diretto superiore.
Nell’emergenza, ovviamente, le magagne si vedono di più. Nella mia città, agli inizi dello scorso marzo, il preside di un liceo VIP ha dichiarato obbligatoria (non infondatamente) la didattica a distanza, mentre il preside di un altro liceo, più popolare, la dichiarava facoltativa, con la motivazione (non infondata nemmeno questa) che non tutti sono tenuti ad avere strumenti per interagire da remoto. I due presidi, palesemente privi di istruzioni, palesemente lasciati soli, parlavano secondo le aspettative dei ‘clienti’. Ma cose del genere, blocco o non blocco, non devono accadere. La reazione dell’istituzione deve essere unica.
La DAD è nata come iniziativa pressoché spontanea, e già solo per questo lodevole. I professori si sono mobilitati subito e hanno garantito presenza, continuità, normalità. Oserei dire che hanno avuto persino una funzione identitaria: private del loro stare insieme, spesso le classi si sono riconosciute come tali solo attraverso il loro professore. I risultati della DAD sono stati per lo più simbolici, ma non è poco, perché i simboli contano, e in certe fasi della vita contano più di tutto il resto.
E tuttavia la DAD non è scuola. Usiamola ancora per settimane, per mesi, per un anno. Usiamola per tutto il tempo necessario. Ma non un minuto in più del necessario. Teniamocela a lungo per tenercela poco: quo longius, eo brevius. Guai se si creasse assuefazione, rassegnazione, abitudine; guai se la DAD diventasse una presenza stabile della nostra vita.
Lei ha scritto: «…le videolezioni non funzionano con i saperi profondi, che si trasmettono non solo con la parola ma anche attraverso il contatto, la prossemica, lo sguardo. Non si tratta di intonacare i muri bensì di gettare le fondamenta forti e durature. Insegnare non è insegnare, ma insegnare a capire se hai capito». Può spiegarci?
Quando uno chiede agli studenti se hanno capito una spiegazione, per lo più rispondono di sì. E per lo più sono sinceri. Ma il professore ha la certezza che le sue parole hanno ‘bucato’ solo se sente intorno a sé quella particolare pressione, quella particolare atmosfera, calda, elettrica, partecipe. Lo so che queste possono sembrare le parole di un romantico visionario, ma chi ha insegnato sa che le cose stanno proprio così. L’apprendimento è mimetico: accetto e faccio mio ciò che mi dici solo se sai convincermi che anche tu sai, che anche tu credi. E non è un accertamento che possa prescindere dalla presenza fisica più di quanto possa prescinderne l’amore: solo guardandoti in faccia posso sapere se mi ami, se non mi ami, se credi o non credi che io ti ami. Gli antichi avevano ragione: la chimica dell’amore e quella della paideia sono uguali: entrambe le cose esigono la totale nudità, la totale immersione nell’altro. Insegnare-tramite-qualcosa ha un valore ipomnematico, di rammemorazione, ma non trasmette sapere. Al di fuori del contatto – e non occasionale, bensì continuo – esiste solo l’apprendimento degli autodidatti, che resta comunque idiosincratico, solipsistico, anche nella vastità e genialità che spesso gli autodidatti hanno.
Quale futuro possiamo immaginare per la scuola?
Se immaginare vuol dire sognare, sogno una scuola di saperi alti, astratti e universali; una scuola formativa e che dia strumenti, che non insegni un mestiere bensì il modo di imparare tutti i mestieri. Una scuola che ricompensi lo studio, che favorisca la mobilità sociale; una scuola che riconquisti la propria specificità, la propria ragione di esistere, la propria ‘missione’. Che per me consiste soprattutto nel contrastare e sfidare i valori dominanti.
Un tempo la scuola era come l’esercito e la Chiesa: una fortezza impenetrabile, che funzionava secondo principii spesso incomprensibili al mondo esterno. Venne il Sessantotto e disse: facciamo entrare la società nella scuola. Giusto. Era ora di finirla con certe ottuse chiusure (sapere tutto di Cicerone e nulla della guerra del Vietnam) e con certi comportamenti (il professore-dio che comanda, lo studente-ilota che esegue e la cui opinione non conta, la famiglia che subisce e tace).
E così la società entrò nella scuola. Ma non si limitò a entrarvi, bensì ne prese possesso, sempre di più plasmandola a sua immagine e utilizzandola come una discarica in cui riversare le responsabilità e i doveri scomodi. Di qui la scuola come nursery, come parrocchia, come ufficio di collocamento. La scuola bonne à tout faire da cui si pretende che insegni divertendo e senza fatica, magicamente, senza interferire con lo sport al pomeriggio, la movida nel dopocena, il weekend nelle seconde case, le vacanze estive, le settimane bianche. E che insegni tutto, anche come si sta a tavola, perché la famiglia ha ormai abdicato dal ruolo educativo primario: i genitori lavorano e quando non lavorano guardano la partita.
Anche i grandi interessi economici sono entrati nella scuola da padroni. Milioni di teenagers da sfruttare, divertire, rimpinzare. Affari colossali. Pensiamo alla fornitura di manodopera gratuita in pretto stile carcerario che chiamano scuola-lavoro; pensiamo ai continui tentativi di adattare il calendario scolastico ai desiderata del turismo: sabati liberi, lotta ai compiti a casa, ipotesi di pause invernali – neanche fossimo oltre il circolo polare artico. Pensiamo alle intoccabili gite, sempre più lunghe, frequenti, costose. Se era ipocrita la scuola in cui si faceva credere che Saffo e le allieve fossero solo buone amiche, che cosa dovremmo dire di una scuola che chiama le gite «viaggi di istruzione»?
O pensiamo infine all’aggressione delle realtà locali, del territorio. Un cumenda produce quaderni? Leviamo di mezzo Dante e facciamo studiare la cellulosa, così i nostri giovani trovano tutti lavoro nella fabbrichetta. Ecco l’integrazione scuola-territorio. Ma se il cumenda chiude? Se si trasferisce in Romania? Per lui è un attimo, la scuola invece ci mette dieci anni per riprogrammarsi.
Toccherebbe agli intellettuali contrastare queste politiche scellerate, invece molti collaborano, forniscono la copertura ideologica. E sono i più pericolosi, perché sanno dove colpire – il miglior ladro è sempre l’ex poliziotto.
Potrei continuare, ma è inutile. E poi, per chi volesse approfondire, consiglio la lettura di due libri: La scuola giusta di Federico Condello (Mondadori 2018), e La scuola dell’ignoranza (Mimesis 2019), una raccolta di saggi curata da Sergio Colella, Dario Generali e Fabio Minazzi (edd.). Due libri preziosi, importantissimi.
Dove ci porterà questo andazzo? Per capirlo basta guardare gli altri, Americani e Francesi in testa. Loro hanno già distrutto la loro scuola, e ora sono terra di conquista di altre scuole più solide e agguerrite, a cominciare dalla nostra. E se noi, nel nostro provincialismo, continueremo a imitarli, a distruggere questo patrimonio che abbiamo, ci troveremo come loro, anzi molto, molto peggio di loro, perché loro hanno risorse, prestigio, influenza. Sono come i compagni di classe ricchi, che cadranno sempre in piedi. Noi invece siamo il compagno povero, per il quale lo studio è la sola speranza.
Un panorama desolante? Lo ammetto. Eppure, nonostante tutto, non sono pessimista. Ho fede nelle energie nascoste, negli esiti illogici, nel paradosso del calabrone. Non si contano le volte in cui mi sono imbattuto in ragazzi che al liceo sembrava non avessero fatto altro che giocare, e che poi sono diventati studenti magnifici. E ciò dimostra che la natura è più forte di tutto: più dei ministri venduti, più degli intellettuali sabotatori, dei pedagogisti ignoranti, dei giostrai, di tutto. È questo pensiero che mi dà la forza di ricominciare ogni anno.















































