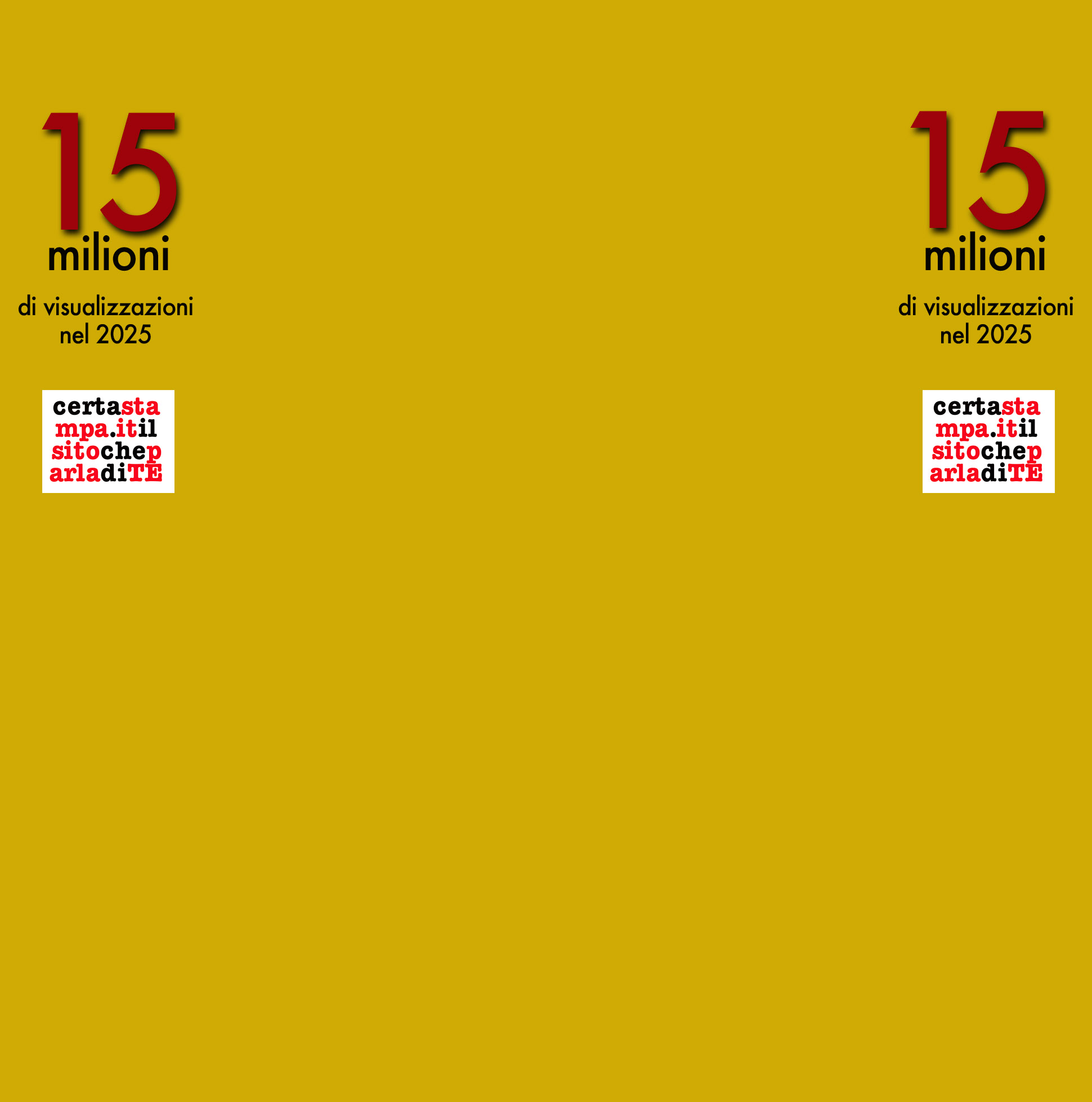Il 3 settembre di 36 anni fa veniva assassinato dalla mafia il Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, assieme alla sua compagna Emanuela Setti Carraro e all’agente della scorta Domenico Russo. L'evento sconvolse il paese e riportò all'attenzione la questione della malavita organizzata che in alcune zone dell'Italia era divenuta un autentico contropotere. L’agguato mortale, dimostrò la potenza ormai raggiunta dalla criminalità organizzata e rese evidente quanto lo stesso Dalla Chiesa poche settimane prima aveva confessato al giornalista Giorgio Bocca, affermando che “lo avevano lasciato solo”.
Dalla Chiesa aveva un legame con la nostra terra. Da giovane carabiniere si batté al fianco dei partigiani in Abruzzo, salvando centinaia di prigionieri inglesi sfuggiti ai tedeschi. Il suo sacrificio di 36 anni fa, anche in termini di gratitudine, richiama direttamente la nostra attenzione.
Perciò, a tanti anni di distanza, è ancora lecito chiedersi se da quell’assassinio sono generate una nuova cultura e nuove modalità di affrontare il fenomeno della malavita organizzata. Ed è altrettanto importante chiedersi se la mafia abbia esteso le sue tentacolari diramazioni in altre zone d’Italia. Tali interrogativi, che ripropongo ora in queste mie considerazioni, sono più che legittimi perché “chiunque pensasse di combattere la mafia nel ‘pascolo’ palermitano, e non nel resto d'Italia, non farebbe che perdere tempo”, come affermò lo stesso dalla Chiesa. Via da me ogni intento allarmistico e tanto meno ogni tentazione di voler attribuire alla malavita organizzata una affiliazione anche nel nostro territorio. Ma credo sia importante fermarsi a riflettere.
Una delle più insidiose attività della criminalità organizzata, è quella di infiltrarsi dentro le istituzioni, permettendo la costante affermazione del disvalore che porta con sé: lo svuotamento delle istituzioni stesse, contrabbandate con i propri modelli, perniciosi e invasivi. E per fare questo utilizza strumenti che inquinano alla base i rapporti democratici, rendendo non di rado ‘normali’ pratiche, comportamenti e modalità d’azione che normali non sono e invece acquisiscono l’aurea di regolarità, avvelenando la convivenza democratica. Penso alla dipendenza che essa sa creare grazie alla mancanza di lavoro; al fascino che suscita con il ricorso al facile guadagno; alla messa in campo di una serie di pratiche capaci di aggirare i procedimenti legislativi e amministrativi per favorire il raggiungimento di obiettivi personali o di gruppo; alla sottomissione fisica e psicologica; all’obbedienza cieca che nella scala gerarchica dei suoi adepti genera assoggettamento e passività; al silenzio – infine – cui le sue pratiche violente e minacciose, costringe.
Da tutto questo scaturiscono acquiescenza, remissività, rassegnazione.
Non faccio fatica a pensare che la politica abbia utilizzato alcune di queste pratiche, dimenticando che essa dovrebbe invece rispondere alle sole regole che possono disciplinarla: lealtà, onestà, responsabilità. E, ancora per citare il generale dalla Chiesa: “Finché una tessera di partito conterà, più dello Stato, non riusciremo mai a battere la mafia”
Come combattere, perciò, un sistema di tal genere? Questa è domanda cui lo Stato deve rispondere. Ma come arginare fenomeni che possono lentamente favorire l’affermazione di gravi e inquietanti comportamenti, è domanda che possiamo farci noi. Io credo che occorra partire dalle scuole. Lasciando da parte tutta quella serie di attività complementari che arricchiscono il curriculum scolastico ma ponendo invece alla base dei comportamenti proprio i sistemi e le pratiche dell’onestà e della responsabilità. Studiare, applicarsi, aiutare chi rimane dietro, fare corpo con i compagni di classe e gli insegnati; e poi condividere con tutte le componenti scolastiche la conoscenza e la convivenza, esportare nelle proprie famiglie un sistema fatto di regole applicate, di comportamenti corretti, di solidarietà reale; questo è un percorso che naturalmente conduce all’affermazione dei diritti collettivi ed individuali, di un sistema che rifiuta il compromesso, che rigetta il favore al singolo e la degenerazione della protezione individuale, che avvelenano le relazioni collettive.
E poi occorrerebbe riconoscere ed assicurare diritti veri a chi non ne ha. Non alludo ai profughi che raggiungono anche la nostra terra, ma penso a tutta quella silenziosa ma enorme quantità di disabili, uomini, donne, anziani abbandonati (torna questa terribile parola) al loro destino di “periferie umane”, come direbbe Papa Francesco. Quando si assicurano i diritti, quando una società e una classe dirigente realizzano l’intelligente operazione della solidarietà reale, non c’è spazio per le infiltrazioni suscitate dal dolore e dal bisogno.
Quando ha subito colpi durissimi, la mafia, è stato anche per il coraggio, il sacrificio, l’ostinazione di chi l’ha combattuta. In questo senso sono amarissime le parole del colonnello Sergio De Caprio, noto come ‘Capitano Ultimo’ e soprattutto per essere l'uomo che ha arrestato il capo dei capi Totò Riina nel 1993, al quale è stata improvvisamente tolta la scorta: «I peggiori sono sempre quelli che rimangono alla finestra a guardare. No abbandono. No omertà». Anche lui, evidentemente, abbandonato dallo Stato, anche lui solo di fronte a tanta pericolosità e minaccia. E’ doveroso rivolgere un appello affinché venga considerata la difficilissima condizione in cui ora viene posto il Capitano Ultimo invitando a una rivisitazione della decisione e un inevitabile passo indietro.
Infine, occorre pretendere dalle istituzioni trasparenza e responsabilità. Usiamo termini inflazionati ma non è forse vero che proprio l’abitudine – come abbiamo provato a dire - genera acritico e arrendevole consenso? Dalla Chiesa richiamava i governanti a queste pratiche. Se, invece di concessioni dei potenti, esse diventano regole, forse tale modello ha meno spazio vitale.
Facciamo in modo anche noi, perciò, che non si continui a parlare di ‘morte inutile’, ma, applicando gli insegnamenti di Dalla Chiesa, proviamo anche da qui, dalla terra dove il giovane Dalla Chiesa cominciò a combattere l’ingiustizia, a respingere con modalità e comportamenti reali, il cancro che da troppo tempo avvelena questo Paese.
Gianguido D’Alberto