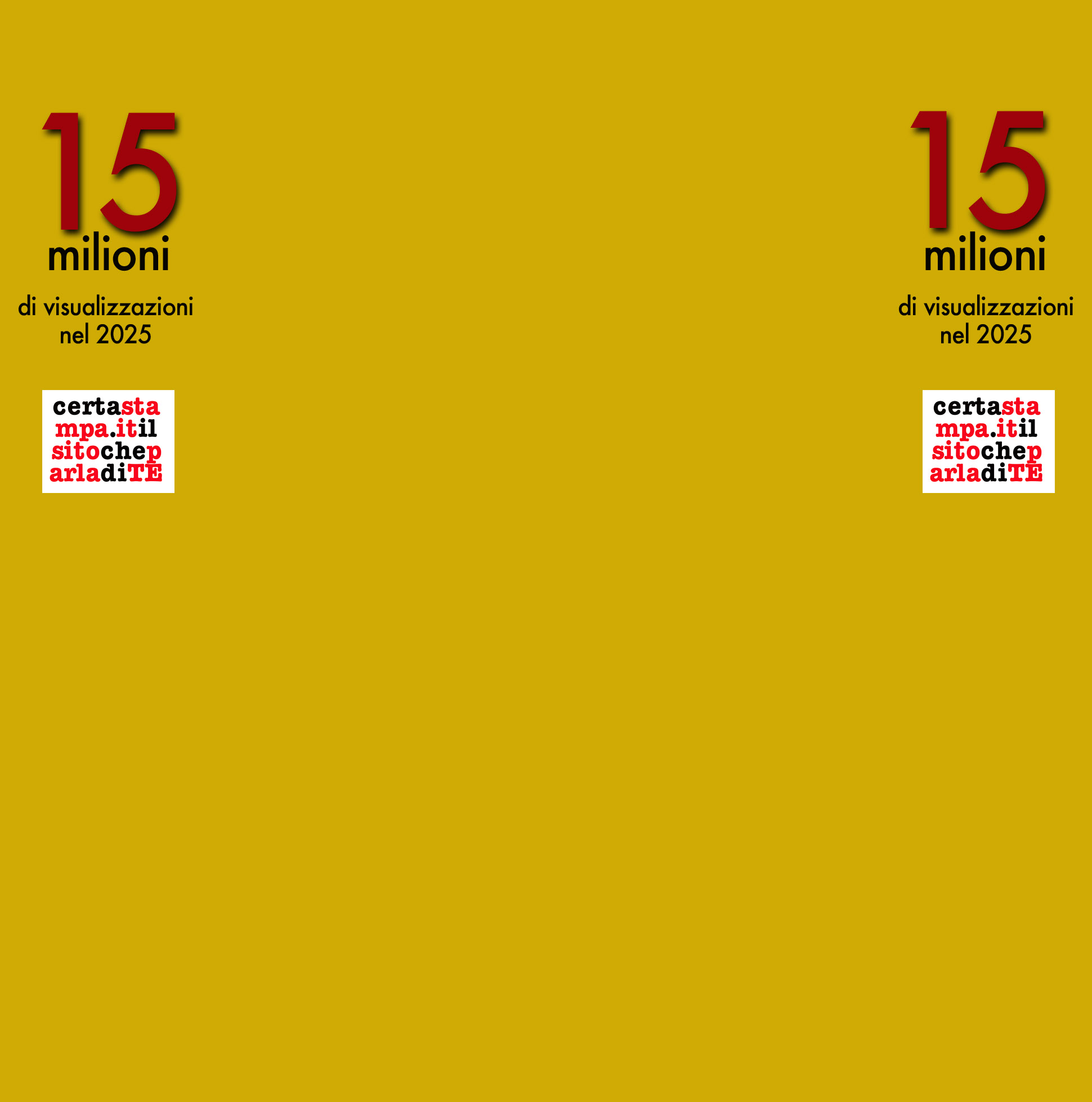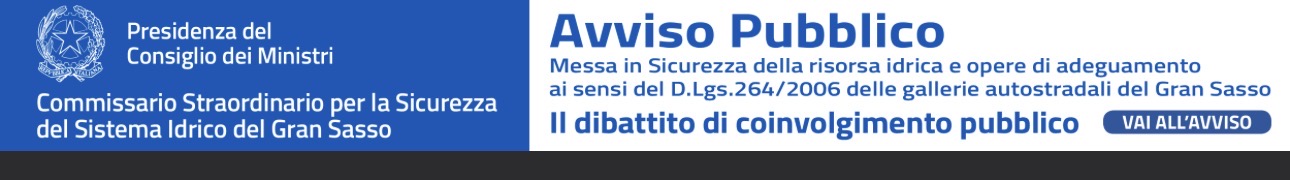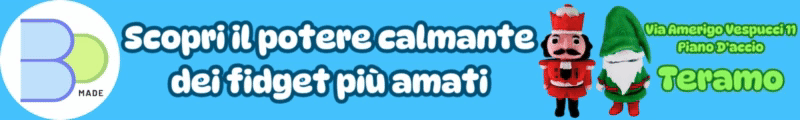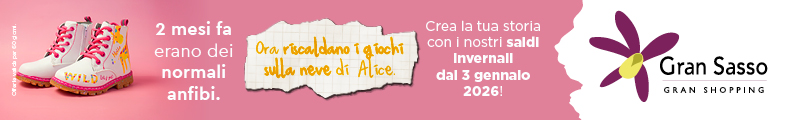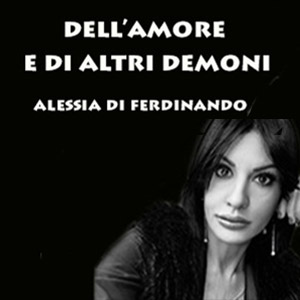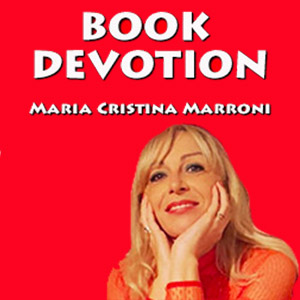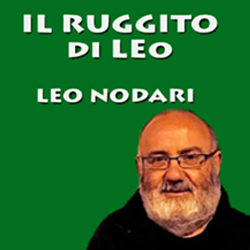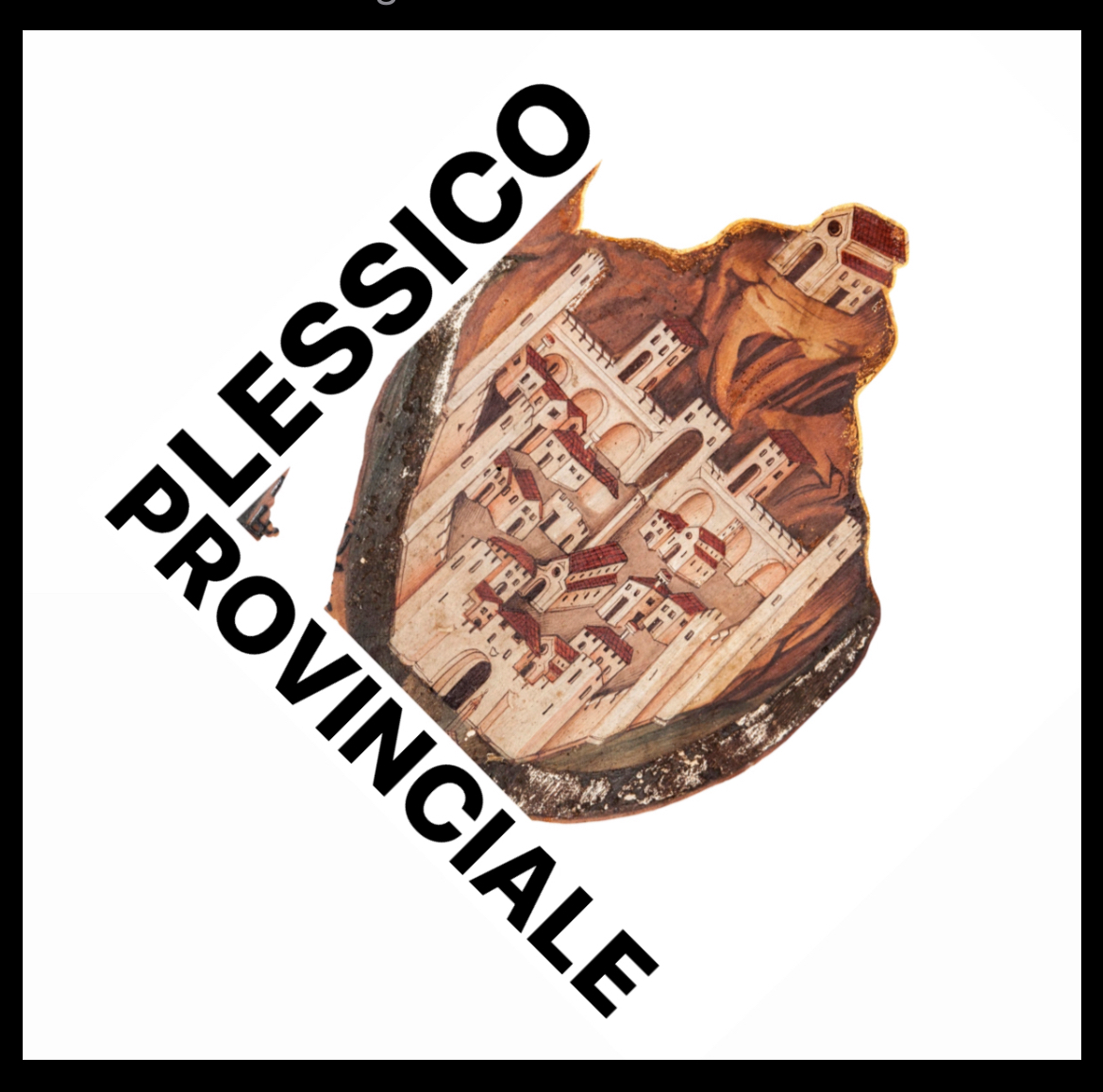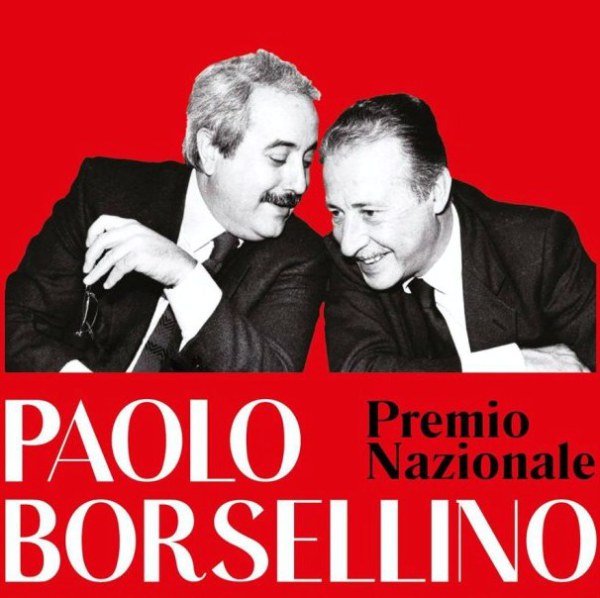Nella sua “Introduzione storico artistica agli studi del piano regolatore della città di Teramo” (Teramo, Casa Editrice Tipografica Teramana, 1934-XII) Luigi Savorini si chiedevacome si dovesse procedere nella sistemazione del centro cittadino e nell’isolamento degli edifici monumentali, primo fra tutti il Duomo e, a seguire, il palazzo vescovile, la loggia comunale e il parlamento, e infine il mercato. La piazza di sopra, intitolata a Vittorio Emanuele (poi ai Martiri della Libertà) non aveva avuto da principio “importanza cittadinesca”, era stato il campo vaccino di Teramo e tale era rimatso sino alla fine del quattrocento, quando il Campano, parlando delle tre piazze che circondavano il palazzo vescovile, la chiamava “forum primum in quo animalia veneunt”. In seguito lo sviluppo della “terranova” aveva portato la piazza superiore a formare un solo grande centro cittadinesco insieme con la parte di sotto, fino a Porta Reale. La sistemazione del centro era intimamente legata al restauro ed all'isolamento degli edifici monumentali che vi campeggiavano, con le loro moli secolari. Altri monumenti medioevali teramani, lontani dal centro, come la casetta col famoso motto “A Lo par lare agi mesura” a Porta Romana e il Chiostro di S. Giovanni, richiedevano urgenti restauri, ma per essi erano già in corso pratiche bene avviate fra il Comune e la Soprintendenza dei Monumenti. La Chiesa di S. Domenico a Porta Romana era stata munificamente restaurata dal Comm. Francesco Savini e solennemente riaperta al pubblico il 17 maggio 1931. Erano edifici che non destano preoccupazioni nel piano regolatore, perché situati in punti nei quali non si prevedevano modificazioni. Il problema artistico era semplificato dal fatto che i monumenti da prendersi in considerazione si trovavano tutti riuniti nel centro ed erano la Loggia Comunale, l’Episcopio, il Duomo. Del Palazzo Comunale si avevano notizie sin dal secolo decimoquinto, quando, come aveva dimostrato il Savini era costituito di tre parti: la loggia inferiore, che accoglieva il parla mento; la sala terrena, addetta alle sentenze; e la sala superiore, ove si adunava il magistrato col giudice ed il consiglio. Rifacimenti subìti da questo edificio, una prima volta nel 1514 e da ultimo più radicalmente e sciaguratamente nel 1857, ne avevanpo distrutta completamente l’eleganza primitiva. Per esigenze di consolidamento si era provveduto ad un incamicia mento, con l'attuale soprastruzione a mattoni di pessimo gusto ottocentesco, che aveva svilito lo svelto edificio del quattrocento tutto in travertino e agli antichi archi acuti si erano sovrappossti, nel piano inferiore, delle arcate a tutto sesto e nel superiore finestroni e balconate nello stile sopra detto. Ne era risultato quel mostruoso pachiderma a tre zampe che ognuno poteva vedere. Tuttavia la loggia antica, che serviva ancora al mercato del grano, si poteva ancora facilmente individuare e recentemente erano stati messi in evidenza i graziosi ornati in terra cotta che ne orlavano gli archi a sesto acuto sul fronte della Piazza del Mercato. La necessità di abbandonare la vecchia sede comunale, divenuta impari ai cresciuti servizi, per costruirla più ampia altrove, nella Piazza Maggiore, aveva fatto sorgere il desiderio di veder isolato e ripristinato il palazzo del Comune medioevale.Ma sotto la moderna incamiciatura, l’antica costruzione sarebbe riapparsa in condizioni di conservazione e di statica tutt’altro che confortanti. Più che ad un restauro si sarebbe dovuto provvedere, e con la maggiore fedeltà possibile, ad un paziente rifacimento.
Nella sua “Introduzione storico artistica agli studi del piano regolatore della città di Teramo” (Teramo, Casa Editrice Tipografica Teramana, 1934-XII) Luigi Savorini si chiedevacome si dovesse procedere nella sistemazione del centro cittadino e nell’isolamento degli edifici monumentali, primo fra tutti il Duomo e, a seguire, il palazzo vescovile, la loggia comunale e il parlamento, e infine il mercato. La piazza di sopra, intitolata a Vittorio Emanuele (poi ai Martiri della Libertà) non aveva avuto da principio “importanza cittadinesca”, era stato il campo vaccino di Teramo e tale era rimatso sino alla fine del quattrocento, quando il Campano, parlando delle tre piazze che circondavano il palazzo vescovile, la chiamava “forum primum in quo animalia veneunt”. In seguito lo sviluppo della “terranova” aveva portato la piazza superiore a formare un solo grande centro cittadinesco insieme con la parte di sotto, fino a Porta Reale. La sistemazione del centro era intimamente legata al restauro ed all'isolamento degli edifici monumentali che vi campeggiavano, con le loro moli secolari. Altri monumenti medioevali teramani, lontani dal centro, come la casetta col famoso motto “A Lo par lare agi mesura” a Porta Romana e il Chiostro di S. Giovanni, richiedevano urgenti restauri, ma per essi erano già in corso pratiche bene avviate fra il Comune e la Soprintendenza dei Monumenti. La Chiesa di S. Domenico a Porta Romana era stata munificamente restaurata dal Comm. Francesco Savini e solennemente riaperta al pubblico il 17 maggio 1931. Erano edifici che non destano preoccupazioni nel piano regolatore, perché situati in punti nei quali non si prevedevano modificazioni. Il problema artistico era semplificato dal fatto che i monumenti da prendersi in considerazione si trovavano tutti riuniti nel centro ed erano la Loggia Comunale, l’Episcopio, il Duomo. Del Palazzo Comunale si avevano notizie sin dal secolo decimoquinto, quando, come aveva dimostrato il Savini era costituito di tre parti: la loggia inferiore, che accoglieva il parla mento; la sala terrena, addetta alle sentenze; e la sala superiore, ove si adunava il magistrato col giudice ed il consiglio. Rifacimenti subìti da questo edificio, una prima volta nel 1514 e da ultimo più radicalmente e sciaguratamente nel 1857, ne avevanpo distrutta completamente l’eleganza primitiva. Per esigenze di consolidamento si era provveduto ad un incamicia mento, con l'attuale soprastruzione a mattoni di pessimo gusto ottocentesco, che aveva svilito lo svelto edificio del quattrocento tutto in travertino e agli antichi archi acuti si erano sovrappossti, nel piano inferiore, delle arcate a tutto sesto e nel superiore finestroni e balconate nello stile sopra detto. Ne era risultato quel mostruoso pachiderma a tre zampe che ognuno poteva vedere. Tuttavia la loggia antica, che serviva ancora al mercato del grano, si poteva ancora facilmente individuare e recentemente erano stati messi in evidenza i graziosi ornati in terra cotta che ne orlavano gli archi a sesto acuto sul fronte della Piazza del Mercato. La necessità di abbandonare la vecchia sede comunale, divenuta impari ai cresciuti servizi, per costruirla più ampia altrove, nella Piazza Maggiore, aveva fatto sorgere il desiderio di veder isolato e ripristinato il palazzo del Comune medioevale.Ma sotto la moderna incamiciatura, l’antica costruzione sarebbe riapparsa in condizioni di conservazione e di statica tutt’altro che confortanti. Più che ad un restauro si sarebbe dovuto provvedere, e con la maggiore fedeltà possibile, ad un paziente rifacimento.
In condizioni analoghe si trovava oggi il Palazzo Vescovile, la cui primitiva costruzione risaliva al secolo decimoterzo. Anch'esso attraverso i vari raffazzonamenti aveva perduto l’eleganza primitiva e lo si vedeva ora poggiare fra le due piazze come un tozzo parallelipipedo impesantito dal barocco delle decorazioni. Sarebbe stato certamente opportuno il restaurarlo, specialmente rifacendo le quattro torrette terminali ai quattro cantoni. Lo si sarebbe visto come lo aveva visto vide il Campano e come lo si vedeva in una antica stampa della “Delfico”, “in arcis modum”, a foggia cioè di turrito castello, con cimature di merli guelfi, con loggiato corrente a pianterreno tutto all'intorno e graziose loggette aperte allo interno e all’esterno del piano superiore. Ma i problemi, della Loggia Comunale e del Palazzo Vescovile si sarebbero imposti in un secondo tempo, più urgente era procedere all'isolamento del Duomo, recentemente ripristinato in tutto l’interno sotto li vescovado di Mons. Settimio Quadraroli e di S. E. Mons. Antonio Micozzi dal compianto architetto Pio Ferretti.Attualmente era il problema edilizio che più appassionava la cittadinanza teramana, era un problema annoso, e nello stesso tempo assai complesso, che le generazioni passate avevano pensato di affrontare e risolvere senza aveva mai il coraggio di farlo. Ma era giunto il momento di provvedere e Savorini all’argomento dedicava grande attenzione conducendo una lucida analisi, sulla quale torneremo. Ma intanto possiamo già chiederci oggi: quello del’isolamento del Duomo fu una scelta indovinata? Fra le necessità addotte a sostegno del progetto di isolamento, Savobribi segnalava le nuove esigenze della viabilità e dei tempi mutati. Il problema, scriveva, era di non lieve difficoltà di attuazione, perché non si trattava di isolare un limitato corpo di fabbrica, ma tre edifici di grande mole: il tempio guidiano del secolo decimosecondo prospiciente sulla piazza inferiore, il tempio arcioniano del secolo decimoquarto, collegato al precedente, ma prospiciente sulla piazza superiore, e il grandioso campanile che s’ergeva sul fianco settentrionale dei due suddetti edifici e quasi nel punto in cui essi s'innestavano. Era un insieme di monumenti che, nel loro perimetro esterno, misuravano una lunghezza di circa trecento metri.
Elso Simone Serpentini